
L’Africa è la terra in cui ha avuto origine l’Homo sapiens. Questi, circa centomila anni fa, ha superato i confini del continente per diffondersi nell’intero pianeta. Ciò nonostante, l’Africa è rimasta a lungo il continente meno conosciuto.
Parlando di Africa, bisogna distinguere quella a nord del grande deserto del Sahara, abitata da popolazioni etnicamente e storicamente legate alle genti mediterranee e medio orientali, la cosiddetta “Africa bianca”, da quella a sud del Sahara, solitamente definita l’”Africa nera” per il colore della pelle dei suoi odierni abitanti. Ma la situazione in passato era alquanto diversa.
La grande fascia della foresta equatoriale era popolata dai pigmei, e, a sud di questa, vivevano i Khoi-San (gli attuali ottentotti e boscimani), mentre l’Africa orientale era abitata da genti definibili “afro-asiatiche”, dal punto di vista etnico-linguistico, per le mescolanze createsi con i continui contatti fra gli abitanti delle due sponde del Mar Rosso. Le popolazioni dai connotati di quanti oggi sono definiti “neri” vivevano prevalentemente nelle savane sub-sahariane della parte occidentale del continente, ove si sono originate. Queste popolazioni, parlanti in prevalenza lingue bantu, divenute agricole, si sono progressivamente diffuse, in successive ondate migratorie, nell’arco di più di mille anni, verso est, e soprattutto verso sud, soppiantando quasi totalmente i pigmei e i boscimani, entrambi cacciatori-raccoglitori, e le genti Khoi (gli ottentotti) dedite alla pastorizia. Ancora nel XVII secolo, gli olandesi, quando fondarono una colonia nel territorio corrispondente all’odierna provincia sudafricana di Città del Capo, si imbatterono nei soli ottentotti, perché le popolazioni bantu non avevano ancora raggiunto l’estremità meridionale del continente. Oggi, in Sud Africa, in Namibia e in Botswana, i Khoi-San sono oggetto di discriminazioni e di mancato riconoscimento della loro identità.
In Occidente, l’Africa nera è considerata da molti un continente senza storia. È un errore perché ci sono stati regni ed imperi, come quelli del Ghana, del Mali, del Singhai, del Dahomey, degli Ashanti e del Congo, Stati di vaste dimensioni, governati da sovrani, coadiuvati da una sorta di aristocrazia, in cui si praticavano commerci su ampia scala, si esercitavano attività artigianali e artistiche di buon livello, con città, talora dotate di scuole. Tuttavia, ovunque l’agricoltura è restata arretrata e scarsamente produttiva, e, pertanto, lo sviluppo tecnico e culturale dell’Africa sud-sahariana è rimasto indietro rispetto all’Europa e all’Asia. Le cause di ciò sono prevalentemente di ordine ambientale.
Le alte temperature unitamente all’elevata umidità delle aree equatoriali, e le piogge abbondanti dei tropici, alternate a stagioni secche, originano terreni acidi e poveri di nutrienti. Inoltre, tali condizioni climatiche danno luogo a processi di laterizzazione con i quali i silicati componenti il suolo si trasformano in idrossidi di alluminio e ferro, producendo terre di colore rosso mattone pressoché sterili. Per limitare tale negativo processo (favorito dall’esposizione della zolle di terra all’aria e al sole), l’agricoltura tradizionale africana ha sempre fatto, giustamente, ricorso a lavorazioni superficiali del terreno, effettuate in genere con la sola zappa, lavorazioni che non consentono comunque significative rese produttive.
A frenare ulteriormente il progresso delle società africane è intervenuta la tratta degli schiavi.
A partire dal VII e VIII secolo, ha preso piede, ad opera di razziatori arabi, la tratta di neri dal Sahel e dall’Africa orientale verso il Nord Africa, l’Arabia e il Medio Oriente. Da quell’epoca fino XIX secolo, si stima che 14-17 milioni di esseri umani siano stati oggetto di questo turpe commercio.
La tratta ad opera di Paesi occidentali iniziò più tardivamente, e precisamente nel XVI secolo, raggiungendo il culmine nel secolo successivo. Ne sono state coinvolte le regioni della costa occidentale africana (dal Senegal all’Angola), e in particolare quelle prospicienti il Golfo di Guinea. Protagonisti di questa attività sono stati gli inglesi e i portoghesi, ai quali è imputabile il 70-75% della tratta, poi i francesi e gli olandesi, e infine, limitatamente, gli spagnoli. Dai porti europei alla costa africana, le navi portavano merci di poco prezzo, chincaglierie e armi; schiavi dalla costa africana alle Americhe; ed infine da queste alla madrepatria, principalmente cotone, zucchero e tabacco, realizzando il cosiddetto commercio triangolare. Si stima che da 9 a 12 milioni di neri siano stati trasportati in catene dall’Africa alle Americhe, senza contare i morti nel viaggio sulla terra ferma africana e in mare.
La tratta degli schiavi ha inciso profondamente sull’intero continente nero. Le popolazioni delle zone costiere, ove avveniva la compravendita, ne traevano vantaggio, e, con le armi ottenute dagli europei, conducevano guerre e scorrerie nelle zone interne per catturare la preziosa merce umana. Ne sono scaturite conseguenze di ordine demografico ed economico ancora oggi avvertibili.
A inizio Ottocento, Europa e Stati Uniti dichiararono illegale il commercio internazionale degli schiavi, e la Gran Bretagna si incaricò di far rispettare il divieto pattugliando l’Atlantico meridionale. I regni africani che avevano prosperato con la tratta decaddero, mentre nuove merci (caffè, cacao, arachidi, olio di palma, avorio) diventarono oggetto di scambi commerciali fra il territorio costiero africano e l’Occidente.
A quel tempo, l’interno del continente nero era sconosciuto agli occidentali. Iniziarono le esplorazioni, e con esse, si accese l’interesse della potenze europee per le risorse delle terre che man mano si venivano a conoscere.
Dal 1881 al 1911, l’intera Africa nera (con l’eccezione dell’Etiopia e della Liberia) venne spartita tra 7 paesi europei: Gran Bretagna, Francia, Portogallo, Belgio, Germania, Italia e Spagna. Il dominio tedesco durò poco perché, già all’inizio della Grande guerra, la Germania venne estromessa dai suoi possedimenti. L’Italia, nel 1935, si impadronì dell’Etiopia, ma perse, con la Seconda guerra mondiale, le proprie colonie mantenendo un mandato temporaneo sulla Somalia.
Con il mutato assetto internazionale seguito alla Seconda guerra mondiale, la decolonizzazione nell’Africa nera ha preso corpo rapidamente alla fine degli anni Cinquanta, a cominciare dai possedimenti inglesi, francesi e belgi; la Spagna ha abbandonato la Guinea Equatoriale nel 1968, e il Sahara Spagnolo nel 1976, mentre il Portogallo ha concesso l’indipendenza alle sue colonie nel 1975 a seguito della “rivoluzione dei garofani”, attuata da quei militari che erano stati partecipi di un lungo e sanguinoso conflitto in terra africana.
Il colonialismo ha influito negativamente sull’Africa con la rapina delle materie prime, l’ineguaglianza degli scambi, lo sfruttamento della mano d’opera di colore, tuttavia, (come ha scritto Alain Caillé) le devastazioni da esso prodotte non sono state esclusivamente di ordine economico, ma sono derivate principalmente dalla perdita di identità dei popoli africani che hanno assistito alla distruzione delle modalità di produzione e riproduzione delle società tradizionali, della cultura e dei simboli che davano senso alla loro esistenza. Così è rimasta ad essi solo l’imitazione dei dominatori.
Dopo un breve periodo di entusiasmo e di speranza per l’indipendenza e la libertà conquistate, le cose presero presto una brutta piega. È del 1962 la pubblicazione di un libro che ebbe vasta risonanza, L’Afrique noire est mal partie, dell’agronomo francese René Dumont. In esso, veniva denunciata l’inadeguatezza dei gruppi dirigenti africani, divenuti presto succubi dei neocolonialisti, e volti a far propri i peggiori aspetti comportamentali dei vecchi dominatori. L’Africa, secondo Dumont, deve porre in primo piano lo sviluppo di una agricoltura idonea a dare cibo a tutti i suoi abitanti; deve rendersi capace di appropriarsi delle risorse di cui è ricca; deve ridefinire le sue strutture politico-amministrative e le istituzioni scolastiche in base alle esigenze della popolazione, e dotarsi di una classe dirigente e di quadri che sappiano riappropriarsi, ammodernandole, delle tradizioni ancora vitali.
Un altro fattore negativo riconducibile al colonialismo riguarda il carattere artificioso degli Stati nati dalla decolonizzazione. Questi hanno mantenuto i medesimi confini, a suo tempo tracciati a tavolino, con squadra e righello, dalle potenze che si sono spartite il continente senza tenere conto della composizione etnica dei territori. Ne sono risultate nazionalità ed etnie divise tra più Stati, mentre ogni Stato comprende genti diverse per lingua, tradizioni e costumi. Mancando ogni identità nazionale, la vita politica dei nuovi Stati è totalmente condizionata dai contrasti tra clan tribali ed etnie. Ne sono scaturiti instabilità e conflitti all’interno degli Stati e fra Stati, scissioni, tentativi di secessione, guerre. Dietro tale conflittualità, sovente, si muovono interessi riconducibili al neocolonialismo che cerca di mettere o mantenere le mani sulle risorse africane, in particolare in territori ricchissimi di materie prime (come è stato ieri nel Katanga, ed oggi nel Kivu).
Negli ultimi anni, pur permanendo i condizionamenti e le interferenze ad opera dei Paesi risalenti all’epoca coloniale e neocoloniale, gli equilibri africani si sono complicati per l’arrivo di nuovi protagonisti (Cina, Russia, Turchia, Arabia Saudita, Emirati arabi e India), nonché per il peso assunto dagli estremisti islamici (Al Qaeda e Isis) nell’area del Sahel.
In questo quadro, ha svolto e svolge un ruolo importante la Santa Sede, grazie alla radicata e capillare rete di missionari e religiosi presenti nel continente nero, e con le molte iniziative diplomatiche (sostenute dalle frequenti visite papali), tese a contrastare le interessate interferenze delle vecchie e nuove potenze, e a sostenere i movimenti politici di ispirazione democratica che lottano contro governi corrotti e i dittature militari.
Pur rimanendo difficile la condizione economica e sociale di larga parte del continente nero, oggi, si intravedono, in alcune sue aree, iniziative in grado di determinare una qualche crescita economica. Si è così formata una “piccola borghesia”, che dispone di più mezzi, istruzione e intraprendenza rispetto al resto della popolazione. E a emigrare sono in prevalenza i membri giovani di questo nuovo ceto, attratti dai modi di vita occidentali, e in cerca di opportunità che il proprio Paese non fornisce loro oggi, e probabilmente nemmeno lo farà domani. Così all’Africa, vengono sottratte risorse umane, di cui ogni Paese ha bisogno, e in particolare quelli più arretrati.
Infine, c’è la questione demografica, che qualcuno non vuol vedere dicendo che, con la crescita economica, presto calerà il numero delle nascite. Ma, ammesso che ciò accada, quanto tempo ci vorrà? Rammento che, nel 1960, l’Africa intera aveva circa 280 milioni di abitanti. Oggi, sono 1 miliardo e 400-500 milioni. Per il 2050, si prevedono 2,5 miliardi di abitanti. Come si spiega? I presidi sanitari efficaci contro le principali malattie infettive sono giunti anche in Africa, per quanto non sempre ovunque, e talora in modo discontinuo o insufficiente. Comunque, è stato molto positivo che siano state salvate e si salvino vite umane, ma Piero Angela, già negli anni Settanta, parlando dell’impatto del progresso medico sulle condizioni di vita, disse che dove giungono gli antibiotici devono arrivare anche i contraccettivi, altrimenti ne consegue una crescita demografica esplosiva con la rottura dell’equilibrio tra carico demografico e risorse del territorio.
C’è poi il cambiamento climatico. Padre Zanotelli ha scritto che, per il 2100, 2/3 del territorio africano potrebbero risultare inabitabili. Sovrapponendosi la crisi climatica all’esplosione demografica, ne risulta una situazione drammatica. Che fare?
Per risparmiare danni non solo agli africani, ma pure a noi europei, perché il collasso dell’Africa sarebbe un disastro per tutti, l’Europa deve agire, e lo deve fare anche se oggi gli africani, memori del passato, guardano con sospetto alle iniziative occidentali, e vanno in cerca di nuovi partner.
Pertanto, bisogna fare tutto ciò che è realisticamente possibile: cancellare i debiti dei Paesi più poveri; porre gli scambi su una base di equità, non rapinando più l’Africa delle sue materie prime; promuovere e sostenere politiche di pianificazione familiare; non intromettersi nelle dispute tra africani pensando di trarne profitto; non inviare o vendere loro armi; non sostenere governi corrotti (autocratici o democratici che siano); accelerare la transizione energetica, fornendo capitali e assistenza tecnica ai Paesi non in grado di far fronte, con i soli propri mezzi, ai progetti di adattamento alla nuova situazione climatica.
In questa direzione, potrebbe andare il piano Mattei, che richiede comunque il coinvolgimento di tutti i Paesi europei, ma penso che l’Africa non possa percorrere la stessa strada seguita dai Paesi dell’Occidente industrializzato per realizzare un analogo modello economico-produttivo, un modello che già non regge più dove è stato creato, e che ritengo non possa sopravvivere al necessario riequilibrio nell’assegnazione delle risorse planetarie: ci vorrebbero infatti le risorse di più pianeti Terra. Per tale motivo, mi pare scarsamente fattibile quell’integrazione economica e politica tra Europa e Africa auspicata da alcune componenti del mondo politico e imprenditoriale.
Ovunque (in Africa come in Europa), il percorso da seguire deve condurre alla realizzazione di un corretto equilibrio tra risorse del territorio e carico demografico con i relativi consumi. Non lo si conseguirà mai se non si cambieranno in profondità gli attuali sistemi economico-produttivi.
Inoltre, i sempre più consistenti flussi migratori, invocati da quanti richiedono l’abbattimento di ogni frontiera, non consentono, a mio parere, di raggiungere l’obiettivo da essi auspicato: diventerebbero presto insostenibili per l’Europa e, nel contempo, non darebbero alcun giovamento alla stragrande maggioranza della popolazione africana, che comunque resterà nel proprio Paese.
Parlando di Africa, bisogna distinguere quella a nord del grande deserto del Sahara, abitata da popolazioni etnicamente e storicamente legate alle genti mediterranee e medio orientali, la cosiddetta “Africa bianca”, da quella a sud del Sahara, solitamente definita l’”Africa nera” per il colore della pelle dei suoi odierni abitanti. Ma la situazione in passato era alquanto diversa.
La grande fascia della foresta equatoriale era popolata dai pigmei, e, a sud di questa, vivevano i Khoi-San (gli attuali ottentotti e boscimani), mentre l’Africa orientale era abitata da genti definibili “afro-asiatiche”, dal punto di vista etnico-linguistico, per le mescolanze createsi con i continui contatti fra gli abitanti delle due sponde del Mar Rosso. Le popolazioni dai connotati di quanti oggi sono definiti “neri” vivevano prevalentemente nelle savane sub-sahariane della parte occidentale del continente, ove si sono originate. Queste popolazioni, parlanti in prevalenza lingue bantu, divenute agricole, si sono progressivamente diffuse, in successive ondate migratorie, nell’arco di più di mille anni, verso est, e soprattutto verso sud, soppiantando quasi totalmente i pigmei e i boscimani, entrambi cacciatori-raccoglitori, e le genti Khoi (gli ottentotti) dedite alla pastorizia. Ancora nel XVII secolo, gli olandesi, quando fondarono una colonia nel territorio corrispondente all’odierna provincia sudafricana di Città del Capo, si imbatterono nei soli ottentotti, perché le popolazioni bantu non avevano ancora raggiunto l’estremità meridionale del continente. Oggi, in Sud Africa, in Namibia e in Botswana, i Khoi-San sono oggetto di discriminazioni e di mancato riconoscimento della loro identità.
In Occidente, l’Africa nera è considerata da molti un continente senza storia. È un errore perché ci sono stati regni ed imperi, come quelli del Ghana, del Mali, del Singhai, del Dahomey, degli Ashanti e del Congo, Stati di vaste dimensioni, governati da sovrani, coadiuvati da una sorta di aristocrazia, in cui si praticavano commerci su ampia scala, si esercitavano attività artigianali e artistiche di buon livello, con città, talora dotate di scuole. Tuttavia, ovunque l’agricoltura è restata arretrata e scarsamente produttiva, e, pertanto, lo sviluppo tecnico e culturale dell’Africa sud-sahariana è rimasto indietro rispetto all’Europa e all’Asia. Le cause di ciò sono prevalentemente di ordine ambientale.
Le alte temperature unitamente all’elevata umidità delle aree equatoriali, e le piogge abbondanti dei tropici, alternate a stagioni secche, originano terreni acidi e poveri di nutrienti. Inoltre, tali condizioni climatiche danno luogo a processi di laterizzazione con i quali i silicati componenti il suolo si trasformano in idrossidi di alluminio e ferro, producendo terre di colore rosso mattone pressoché sterili. Per limitare tale negativo processo (favorito dall’esposizione della zolle di terra all’aria e al sole), l’agricoltura tradizionale africana ha sempre fatto, giustamente, ricorso a lavorazioni superficiali del terreno, effettuate in genere con la sola zappa, lavorazioni che non consentono comunque significative rese produttive.
A frenare ulteriormente il progresso delle società africane è intervenuta la tratta degli schiavi.
A partire dal VII e VIII secolo, ha preso piede, ad opera di razziatori arabi, la tratta di neri dal Sahel e dall’Africa orientale verso il Nord Africa, l’Arabia e il Medio Oriente. Da quell’epoca fino XIX secolo, si stima che 14-17 milioni di esseri umani siano stati oggetto di questo turpe commercio.
La tratta ad opera di Paesi occidentali iniziò più tardivamente, e precisamente nel XVI secolo, raggiungendo il culmine nel secolo successivo. Ne sono state coinvolte le regioni della costa occidentale africana (dal Senegal all’Angola), e in particolare quelle prospicienti il Golfo di Guinea. Protagonisti di questa attività sono stati gli inglesi e i portoghesi, ai quali è imputabile il 70-75% della tratta, poi i francesi e gli olandesi, e infine, limitatamente, gli spagnoli. Dai porti europei alla costa africana, le navi portavano merci di poco prezzo, chincaglierie e armi; schiavi dalla costa africana alle Americhe; ed infine da queste alla madrepatria, principalmente cotone, zucchero e tabacco, realizzando il cosiddetto commercio triangolare. Si stima che da 9 a 12 milioni di neri siano stati trasportati in catene dall’Africa alle Americhe, senza contare i morti nel viaggio sulla terra ferma africana e in mare.
La tratta degli schiavi ha inciso profondamente sull’intero continente nero. Le popolazioni delle zone costiere, ove avveniva la compravendita, ne traevano vantaggio, e, con le armi ottenute dagli europei, conducevano guerre e scorrerie nelle zone interne per catturare la preziosa merce umana. Ne sono scaturite conseguenze di ordine demografico ed economico ancora oggi avvertibili.
A inizio Ottocento, Europa e Stati Uniti dichiararono illegale il commercio internazionale degli schiavi, e la Gran Bretagna si incaricò di far rispettare il divieto pattugliando l’Atlantico meridionale. I regni africani che avevano prosperato con la tratta decaddero, mentre nuove merci (caffè, cacao, arachidi, olio di palma, avorio) diventarono oggetto di scambi commerciali fra il territorio costiero africano e l’Occidente.
A quel tempo, l’interno del continente nero era sconosciuto agli occidentali. Iniziarono le esplorazioni, e con esse, si accese l’interesse della potenze europee per le risorse delle terre che man mano si venivano a conoscere.
Dal 1881 al 1911, l’intera Africa nera (con l’eccezione dell’Etiopia e della Liberia) venne spartita tra 7 paesi europei: Gran Bretagna, Francia, Portogallo, Belgio, Germania, Italia e Spagna. Il dominio tedesco durò poco perché, già all’inizio della Grande guerra, la Germania venne estromessa dai suoi possedimenti. L’Italia, nel 1935, si impadronì dell’Etiopia, ma perse, con la Seconda guerra mondiale, le proprie colonie mantenendo un mandato temporaneo sulla Somalia.
Con il mutato assetto internazionale seguito alla Seconda guerra mondiale, la decolonizzazione nell’Africa nera ha preso corpo rapidamente alla fine degli anni Cinquanta, a cominciare dai possedimenti inglesi, francesi e belgi; la Spagna ha abbandonato la Guinea Equatoriale nel 1968, e il Sahara Spagnolo nel 1976, mentre il Portogallo ha concesso l’indipendenza alle sue colonie nel 1975 a seguito della “rivoluzione dei garofani”, attuata da quei militari che erano stati partecipi di un lungo e sanguinoso conflitto in terra africana.
Il colonialismo ha influito negativamente sull’Africa con la rapina delle materie prime, l’ineguaglianza degli scambi, lo sfruttamento della mano d’opera di colore, tuttavia, (come ha scritto Alain Caillé) le devastazioni da esso prodotte non sono state esclusivamente di ordine economico, ma sono derivate principalmente dalla perdita di identità dei popoli africani che hanno assistito alla distruzione delle modalità di produzione e riproduzione delle società tradizionali, della cultura e dei simboli che davano senso alla loro esistenza. Così è rimasta ad essi solo l’imitazione dei dominatori.
Dopo un breve periodo di entusiasmo e di speranza per l’indipendenza e la libertà conquistate, le cose presero presto una brutta piega. È del 1962 la pubblicazione di un libro che ebbe vasta risonanza, L’Afrique noire est mal partie, dell’agronomo francese René Dumont. In esso, veniva denunciata l’inadeguatezza dei gruppi dirigenti africani, divenuti presto succubi dei neocolonialisti, e volti a far propri i peggiori aspetti comportamentali dei vecchi dominatori. L’Africa, secondo Dumont, deve porre in primo piano lo sviluppo di una agricoltura idonea a dare cibo a tutti i suoi abitanti; deve rendersi capace di appropriarsi delle risorse di cui è ricca; deve ridefinire le sue strutture politico-amministrative e le istituzioni scolastiche in base alle esigenze della popolazione, e dotarsi di una classe dirigente e di quadri che sappiano riappropriarsi, ammodernandole, delle tradizioni ancora vitali.
Un altro fattore negativo riconducibile al colonialismo riguarda il carattere artificioso degli Stati nati dalla decolonizzazione. Questi hanno mantenuto i medesimi confini, a suo tempo tracciati a tavolino, con squadra e righello, dalle potenze che si sono spartite il continente senza tenere conto della composizione etnica dei territori. Ne sono risultate nazionalità ed etnie divise tra più Stati, mentre ogni Stato comprende genti diverse per lingua, tradizioni e costumi. Mancando ogni identità nazionale, la vita politica dei nuovi Stati è totalmente condizionata dai contrasti tra clan tribali ed etnie. Ne sono scaturiti instabilità e conflitti all’interno degli Stati e fra Stati, scissioni, tentativi di secessione, guerre. Dietro tale conflittualità, sovente, si muovono interessi riconducibili al neocolonialismo che cerca di mettere o mantenere le mani sulle risorse africane, in particolare in territori ricchissimi di materie prime (come è stato ieri nel Katanga, ed oggi nel Kivu).
Negli ultimi anni, pur permanendo i condizionamenti e le interferenze ad opera dei Paesi risalenti all’epoca coloniale e neocoloniale, gli equilibri africani si sono complicati per l’arrivo di nuovi protagonisti (Cina, Russia, Turchia, Arabia Saudita, Emirati arabi e India), nonché per il peso assunto dagli estremisti islamici (Al Qaeda e Isis) nell’area del Sahel.
In questo quadro, ha svolto e svolge un ruolo importante la Santa Sede, grazie alla radicata e capillare rete di missionari e religiosi presenti nel continente nero, e con le molte iniziative diplomatiche (sostenute dalle frequenti visite papali), tese a contrastare le interessate interferenze delle vecchie e nuove potenze, e a sostenere i movimenti politici di ispirazione democratica che lottano contro governi corrotti e i dittature militari.
Pur rimanendo difficile la condizione economica e sociale di larga parte del continente nero, oggi, si intravedono, in alcune sue aree, iniziative in grado di determinare una qualche crescita economica. Si è così formata una “piccola borghesia”, che dispone di più mezzi, istruzione e intraprendenza rispetto al resto della popolazione. E a emigrare sono in prevalenza i membri giovani di questo nuovo ceto, attratti dai modi di vita occidentali, e in cerca di opportunità che il proprio Paese non fornisce loro oggi, e probabilmente nemmeno lo farà domani. Così all’Africa, vengono sottratte risorse umane, di cui ogni Paese ha bisogno, e in particolare quelli più arretrati.
Infine, c’è la questione demografica, che qualcuno non vuol vedere dicendo che, con la crescita economica, presto calerà il numero delle nascite. Ma, ammesso che ciò accada, quanto tempo ci vorrà? Rammento che, nel 1960, l’Africa intera aveva circa 280 milioni di abitanti. Oggi, sono 1 miliardo e 400-500 milioni. Per il 2050, si prevedono 2,5 miliardi di abitanti. Come si spiega? I presidi sanitari efficaci contro le principali malattie infettive sono giunti anche in Africa, per quanto non sempre ovunque, e talora in modo discontinuo o insufficiente. Comunque, è stato molto positivo che siano state salvate e si salvino vite umane, ma Piero Angela, già negli anni Settanta, parlando dell’impatto del progresso medico sulle condizioni di vita, disse che dove giungono gli antibiotici devono arrivare anche i contraccettivi, altrimenti ne consegue una crescita demografica esplosiva con la rottura dell’equilibrio tra carico demografico e risorse del territorio.
C’è poi il cambiamento climatico. Padre Zanotelli ha scritto che, per il 2100, 2/3 del territorio africano potrebbero risultare inabitabili. Sovrapponendosi la crisi climatica all’esplosione demografica, ne risulta una situazione drammatica. Che fare?
Per risparmiare danni non solo agli africani, ma pure a noi europei, perché il collasso dell’Africa sarebbe un disastro per tutti, l’Europa deve agire, e lo deve fare anche se oggi gli africani, memori del passato, guardano con sospetto alle iniziative occidentali, e vanno in cerca di nuovi partner.
Pertanto, bisogna fare tutto ciò che è realisticamente possibile: cancellare i debiti dei Paesi più poveri; porre gli scambi su una base di equità, non rapinando più l’Africa delle sue materie prime; promuovere e sostenere politiche di pianificazione familiare; non intromettersi nelle dispute tra africani pensando di trarne profitto; non inviare o vendere loro armi; non sostenere governi corrotti (autocratici o democratici che siano); accelerare la transizione energetica, fornendo capitali e assistenza tecnica ai Paesi non in grado di far fronte, con i soli propri mezzi, ai progetti di adattamento alla nuova situazione climatica.
In questa direzione, potrebbe andare il piano Mattei, che richiede comunque il coinvolgimento di tutti i Paesi europei, ma penso che l’Africa non possa percorrere la stessa strada seguita dai Paesi dell’Occidente industrializzato per realizzare un analogo modello economico-produttivo, un modello che già non regge più dove è stato creato, e che ritengo non possa sopravvivere al necessario riequilibrio nell’assegnazione delle risorse planetarie: ci vorrebbero infatti le risorse di più pianeti Terra. Per tale motivo, mi pare scarsamente fattibile quell’integrazione economica e politica tra Europa e Africa auspicata da alcune componenti del mondo politico e imprenditoriale.
Ovunque (in Africa come in Europa), il percorso da seguire deve condurre alla realizzazione di un corretto equilibrio tra risorse del territorio e carico demografico con i relativi consumi. Non lo si conseguirà mai se non si cambieranno in profondità gli attuali sistemi economico-produttivi.
Inoltre, i sempre più consistenti flussi migratori, invocati da quanti richiedono l’abbattimento di ogni frontiera, non consentono, a mio parere, di raggiungere l’obiettivo da essi auspicato: diventerebbero presto insostenibili per l’Europa e, nel contempo, non darebbero alcun giovamento alla stragrande maggioranza della popolazione africana, che comunque resterà nel proprio Paese.
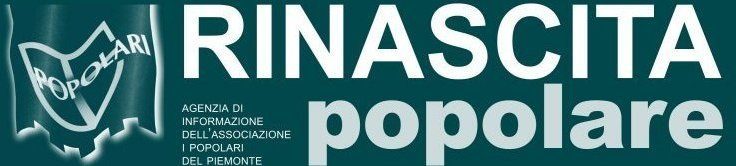
Ottima analisi. Grazie.
Magistrale “lezione” quella di Ladetto. Inserisco il link a due interessanti interviste rilasciate da Mario Giro (membro della Comunità di s.Egidio, docente di Relazioni internazionali e ex viceministro degli esteri nel governo Letta) che ha pubblicato e curato un importante volume sul piano Mattei.(Guerini e Associati). https://www.geopolitica.info/piano-mattei/ – https://www.unita.it/2023/09/13/leuropa-fa-i-piani-ma-lafrica-vuole-essere-padrona-del-proprio-destino-parla-mario-giro/