
Alla notizia dell’incontro di Trump e Putin in Alaska, per cercare di porre fine alla guerra in Ucraina, subito la Commissione della UE, i principali Paesi comunitari e il Regno Unito si sono attivati per ostacolare tale vertice. A incontro avvenuto, ne hanno criticato il risultato, ritenuto inconcludente, e ora, nei colloqui tenuti alla Casa Bianca e nei successivi contatti, pongono pesanti condizioni (pare con qualche risultato) all’intesa con Mosca.
A motivare tale comportamento, invocano la necessità di una tregua immediata, alla quale, per il raggiungimento di una pace giusta, seguano serie trattative con la piena partecipazione dell’Ucraina e dei Paesi europei. Ogni soluzione, inoltre, deve fare riferimento al diritto internazionale che non ammette modificazioni con la forza militare dei confini territoriali di uno Stato.
Molte guerre hanno avuto fine con la vittoria piena di una parte e la capitolazione dell’avversario, a cui è stata imposta una pace senza condizioni, che sovente ha condotto ad ampie amputazioni territoriali, e talora alla disgregazione del Paese vinto. Altre sono terminate quando entrambi i contendenti hanno ritenuto di aver speso troppo in vite umane e risorse, e, pertanto, sono addivenuti a una tregua (che in genere congela la situazione territoriale sul campo) per aprire la strada ad un armistizio, seguito – ma non sempre, vedi la guerra di Corea – da un trattato di pace.
Al momento, tali possibili esiti non sembrano riguardare il conflitto ucraino, per il quale si cerca di realizzare una pace di compromesso. Essa generalmente richiede la mediazione di Paesi terzi interessati alla fine del conflitto per le sue ricadute negative a livello internazionale. Oggi, questo compito di mediazione viene esercitato (sia pure con grande difficoltà) dagli Stati Uniti di Trump.
Teniamo conto che, per esercitare una mediazione e mettere in piedi una pace di compromesso, occorre uscire dalla logica del “buono” contro il “cattivo”, ma piuttosto approfondire le motivazioni che hanno causato la guerra, e tenere conto delle ragioni addotte da ciascuna delle due parti. Inoltre, hanno inevitabilmente peso sulle soluzioni proponibili anche i rapporti di forza determinatisi sul campo di battaglia.
La pace giusta, nei termini rivendicati dai Paesi comunitari, non è riconducibile a un tale percorso, ma solo potrebbe essere imposta a una Russia militarmente sconfitta. Pertanto, si traduce, di fatto, nella volontà di continuare la guerra, o di protrarla in attesa di qualche evento che ne modifichi il corso attuale.
Chiediamoci in che prospettiva si collochi questo atteggiamento. Si possono fare solo delle ipotesi.
a) Condurre avanti la guerra in vista di una controffensiva ucraina, sostenuta con nuovi apporti di armi occidentali, proponendosi, nel contempo, di ottenere un ulteriore indebolimento russo a seguito di nuove pesanti sanzioni; il tutto per consentire a Kiev di arrivare a una trattativa con più carte in mano da giocare. Tuttavia, una prossima vittoriosa controffensiva ucraina era già stata prevista negli anni scorsi, ma non ha mai preso corpo, se non con l’avanzata in territorio russo nella regione di Kursk, offensiva presto respinta. Oggi, con una opinione pubblica ucraina scoraggiata che chiede la fine immediata della guerra, una nuova offensiva è improponibile. Anche le sanzioni alla Russia non sembrano in grado di far crollare a breve il sistema economico-produttivo di Mosca.
b) Protrarre la guerra nella speranza che Trump (pressato dagli alleati europei) cambi atteggiamento e si schieri totalmente dalla parte di Kiev, ciò che ne rafforzerebbe anche le capacità negoziali. Tutto può succedere con Trump, ma non è (come viene descritto) un soggetto meramente intento a magnificare l’immagine di se stesso come pacificatore; avverte anche la necessità (in sintonia con il Pentagono) di disimpegnare l’America da un conflitto regionale, già durato troppo a lungo, per riservare le forze militari ad altri più pressanti compiti, in uno scenario planetario ove le priorità riguardano l’Estremo Oriente e l’area del Pacifico.
c) Infine, dilazionare accordi in attesa di condizioni favorevoli a una eventuale diretta discesa su suolo ucraino di forze combattenti europee (i volenterosi?), un intento a cui non voglio dare alcun credito perché, se mai qualcuno lo concepisse, sarebbe non solo velleitario, ma poco responsabile e assai pericoloso per tutti.
Mi sembrano, pertanto, tutte aspettative irrealistiche.
Per quali motivi, l’Europa comunitaria ha assunto e mantiene ancora questo atteggiamento intransigente?
Metto da parte il continuo richiamo al diritto internazionale, puramente strumentale, perché nessuno ha titoli per invocarlo, visti i molti precedenti non commendevoli riguardanti anche Paesi della NATO. Restano, pertanto, altre motivazioni.
Si teme che la Russia, se non viene fermata in Ucraina, presto minaccerà altri Paesi europei e la stessa Unione Europea. Ma non c’è certo bisogno di essere un esperto di geopolitica per comprendere che una Russia con un PIL di poco più di 2000 miliardi di dollari (pari al solo PIL italiano) non possa sostenere economicamente una condotta aggressiva nei confronti di una UE che (anche senza tener conto della NATO) ha un potenziale economico (a cui si ricollega anche la sostenibilità della spesa militare), nonché tecnologico e produttivo grandemente superiore al suo. La guerra in Ucraina, per la Russia, resta legata a un contesto regionale dove, in un Paese strategicamente vitale, non accetta, per ragioni di sicurezza, la presenza di governi ostili.
Quindi l’obiettivo di Mosca pare territorialmente circoscritto, ma per la UE è comunque inammissibile, e va respinta anche la pretesa russa di condizionare i Paesi inseriti nella sua presunta area di sicurezza, limitandone scelte ed orientamenti in campo internazionale. Chiediamoci allora cosa farebbero gli Stati Uniti (chiunque ne fosse al governo) se il Messico (oppure Panama) decidesse di ospitare basi militari cinesi. La risposta l’abbiamo già avuta nel 1962 con la crisi dei missili a Cuba, quando per un pelo non si arrivò a una guerra nucleare.
Oggi, i leader dei Paesi europei e il vertice della UE sentono la necessità di rilanciare la propria immagine da tempo alquanto sbiadita, per essere sempre stati accantonati da Washington al momento delle decisioni importanti (ad esempio, l’abbandono repentino dell’Afghanistan, senza previa consultazione) e, oggi, umiliati per aver subito senza fiatare le imposizioni di Trump in tema di riarmo e di dazi. Inoltre, se, dopo il rilevante e dispendioso aiuto fornito a Kiev e le impegnative dichiarazioni di sostegno, non ottenessero la auspicata “pace giusta”, o qualcosa di simile, evidenzierebbero ancora una volta la propria irrilevanza.
Pertanto, come se l’Europa fosse ancora al centro del mondo, i predetti leader tentano di ritornare protagonisti presentandosi come i principali, se non i soli, intransigenti difensori di quei valori occidentali ereditati dall’illuminismo (nella convinzione che l’America di Trump se ne stia allontanando), valori che vorrebbero poter esportare ovunque, a partire dall’Europa orientale.
Ma per una Europa ormai invecchiata, è questa un’impresa estremamente impegnativa, onerosa e irta di pericoli, che, ai più, pare fuori della sua portata. In ogni caso, sarebbe opportuno conoscere in materia cosa pensa la maggioranza dei cittadini europei.
A motivare tale comportamento, invocano la necessità di una tregua immediata, alla quale, per il raggiungimento di una pace giusta, seguano serie trattative con la piena partecipazione dell’Ucraina e dei Paesi europei. Ogni soluzione, inoltre, deve fare riferimento al diritto internazionale che non ammette modificazioni con la forza militare dei confini territoriali di uno Stato.
Molte guerre hanno avuto fine con la vittoria piena di una parte e la capitolazione dell’avversario, a cui è stata imposta una pace senza condizioni, che sovente ha condotto ad ampie amputazioni territoriali, e talora alla disgregazione del Paese vinto. Altre sono terminate quando entrambi i contendenti hanno ritenuto di aver speso troppo in vite umane e risorse, e, pertanto, sono addivenuti a una tregua (che in genere congela la situazione territoriale sul campo) per aprire la strada ad un armistizio, seguito – ma non sempre, vedi la guerra di Corea – da un trattato di pace.
Al momento, tali possibili esiti non sembrano riguardare il conflitto ucraino, per il quale si cerca di realizzare una pace di compromesso. Essa generalmente richiede la mediazione di Paesi terzi interessati alla fine del conflitto per le sue ricadute negative a livello internazionale. Oggi, questo compito di mediazione viene esercitato (sia pure con grande difficoltà) dagli Stati Uniti di Trump.
Teniamo conto che, per esercitare una mediazione e mettere in piedi una pace di compromesso, occorre uscire dalla logica del “buono” contro il “cattivo”, ma piuttosto approfondire le motivazioni che hanno causato la guerra, e tenere conto delle ragioni addotte da ciascuna delle due parti. Inoltre, hanno inevitabilmente peso sulle soluzioni proponibili anche i rapporti di forza determinatisi sul campo di battaglia.
La pace giusta, nei termini rivendicati dai Paesi comunitari, non è riconducibile a un tale percorso, ma solo potrebbe essere imposta a una Russia militarmente sconfitta. Pertanto, si traduce, di fatto, nella volontà di continuare la guerra, o di protrarla in attesa di qualche evento che ne modifichi il corso attuale.
Chiediamoci in che prospettiva si collochi questo atteggiamento. Si possono fare solo delle ipotesi.
a) Condurre avanti la guerra in vista di una controffensiva ucraina, sostenuta con nuovi apporti di armi occidentali, proponendosi, nel contempo, di ottenere un ulteriore indebolimento russo a seguito di nuove pesanti sanzioni; il tutto per consentire a Kiev di arrivare a una trattativa con più carte in mano da giocare. Tuttavia, una prossima vittoriosa controffensiva ucraina era già stata prevista negli anni scorsi, ma non ha mai preso corpo, se non con l’avanzata in territorio russo nella regione di Kursk, offensiva presto respinta. Oggi, con una opinione pubblica ucraina scoraggiata che chiede la fine immediata della guerra, una nuova offensiva è improponibile. Anche le sanzioni alla Russia non sembrano in grado di far crollare a breve il sistema economico-produttivo di Mosca.
b) Protrarre la guerra nella speranza che Trump (pressato dagli alleati europei) cambi atteggiamento e si schieri totalmente dalla parte di Kiev, ciò che ne rafforzerebbe anche le capacità negoziali. Tutto può succedere con Trump, ma non è (come viene descritto) un soggetto meramente intento a magnificare l’immagine di se stesso come pacificatore; avverte anche la necessità (in sintonia con il Pentagono) di disimpegnare l’America da un conflitto regionale, già durato troppo a lungo, per riservare le forze militari ad altri più pressanti compiti, in uno scenario planetario ove le priorità riguardano l’Estremo Oriente e l’area del Pacifico.
c) Infine, dilazionare accordi in attesa di condizioni favorevoli a una eventuale diretta discesa su suolo ucraino di forze combattenti europee (i volenterosi?), un intento a cui non voglio dare alcun credito perché, se mai qualcuno lo concepisse, sarebbe non solo velleitario, ma poco responsabile e assai pericoloso per tutti.
Mi sembrano, pertanto, tutte aspettative irrealistiche.
Per quali motivi, l’Europa comunitaria ha assunto e mantiene ancora questo atteggiamento intransigente?
Metto da parte il continuo richiamo al diritto internazionale, puramente strumentale, perché nessuno ha titoli per invocarlo, visti i molti precedenti non commendevoli riguardanti anche Paesi della NATO. Restano, pertanto, altre motivazioni.
Si teme che la Russia, se non viene fermata in Ucraina, presto minaccerà altri Paesi europei e la stessa Unione Europea. Ma non c’è certo bisogno di essere un esperto di geopolitica per comprendere che una Russia con un PIL di poco più di 2000 miliardi di dollari (pari al solo PIL italiano) non possa sostenere economicamente una condotta aggressiva nei confronti di una UE che (anche senza tener conto della NATO) ha un potenziale economico (a cui si ricollega anche la sostenibilità della spesa militare), nonché tecnologico e produttivo grandemente superiore al suo. La guerra in Ucraina, per la Russia, resta legata a un contesto regionale dove, in un Paese strategicamente vitale, non accetta, per ragioni di sicurezza, la presenza di governi ostili.
Quindi l’obiettivo di Mosca pare territorialmente circoscritto, ma per la UE è comunque inammissibile, e va respinta anche la pretesa russa di condizionare i Paesi inseriti nella sua presunta area di sicurezza, limitandone scelte ed orientamenti in campo internazionale. Chiediamoci allora cosa farebbero gli Stati Uniti (chiunque ne fosse al governo) se il Messico (oppure Panama) decidesse di ospitare basi militari cinesi. La risposta l’abbiamo già avuta nel 1962 con la crisi dei missili a Cuba, quando per un pelo non si arrivò a una guerra nucleare.
Oggi, i leader dei Paesi europei e il vertice della UE sentono la necessità di rilanciare la propria immagine da tempo alquanto sbiadita, per essere sempre stati accantonati da Washington al momento delle decisioni importanti (ad esempio, l’abbandono repentino dell’Afghanistan, senza previa consultazione) e, oggi, umiliati per aver subito senza fiatare le imposizioni di Trump in tema di riarmo e di dazi. Inoltre, se, dopo il rilevante e dispendioso aiuto fornito a Kiev e le impegnative dichiarazioni di sostegno, non ottenessero la auspicata “pace giusta”, o qualcosa di simile, evidenzierebbero ancora una volta la propria irrilevanza.
Pertanto, come se l’Europa fosse ancora al centro del mondo, i predetti leader tentano di ritornare protagonisti presentandosi come i principali, se non i soli, intransigenti difensori di quei valori occidentali ereditati dall’illuminismo (nella convinzione che l’America di Trump se ne stia allontanando), valori che vorrebbero poter esportare ovunque, a partire dall’Europa orientale.
Ma per una Europa ormai invecchiata, è questa un’impresa estremamente impegnativa, onerosa e irta di pericoli, che, ai più, pare fuori della sua portata. In ogni caso, sarebbe opportuno conoscere in materia cosa pensa la maggioranza dei cittadini europei.
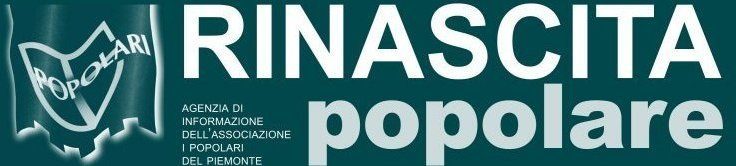
Un giudizio che mette tutti d’accordo è il riarmo ragionato e senza sovrapposizioni di eserciti, l’ammiraglio Nato Cavo Dragone sostiene: “Bene la difesa comune, ma non ci sarà un esercito Ue. La guerra non conviene neanche a Mosca, è un azzardo pericoloso, la Russia sta pagando un prezzo altissimo”, le autorità russe sono consapevoli di questa realtà e del fatto che dovranno fare i conti con un dopoguerra non facile”. Cavo Dragone sulla paventata frattura Nato: non vede il rischio! E sulle garanzie per Kiev sottolinea: ”La prima garanzia continueranno a essere le Forze Armate ucraine. Kiev continuerà a ricevere da più paesi sostenitori importanti contributi”. Quanto alle garanzie politiche ”saranno definite da un giusto accordo di pace, che per essere anche duraturo, dovrà essere valido per le parti coinvolte”, preferibilmente sotto egida Onu. Una forza credibile, multinazionale non solo di forze europee, una presenza significativa lungo tutto il confine russo-ucraino”. Quindi più che di esercito comune, si parlerà di missioni che devono avere come denominatore forze intercambiabili”. E’ ovvio che l’intento di tutte queste iniziative è quello di conferire all’Europa una maggiore autonomia operativa basata su prodotti e/o tecnologie made in USA. Un mix intelligente (i missili antiaerei Patriot, ad esempio, sono costruiti anche in Germania su licenza americana), ciò permette un’emancipazione più morbida e graduale senza offrire a Trump pretesti per altre escalation anti-europee. (…). Su una cosa tutta l’UE deve essere d’accordo bloccare l’ingresso in Europa e in Italia di ulteriori islamici, la Sharia porta discordia nel mondo. Il nascente conflitto tra Pakistan e India, due potenze nucleari dove le armi convenzionali hanno un valore relativo.
a) la globalizzazione è un fallimento che ha innescato conflitti in tutto il mondo
b) la decarbonazione e segregazione della CO2 una truffa
c) il riarmo dell’Europa una follia: “aumentare la spesa militare” è una scelta mostruosa.
Per far cessare la guerra russo-ucraina, provocata da Zelesnky, iniziata da Putin ma sostenuta da USA e NATO; la Crimea e i territori conquistati da Mosca dovranno far parte della Federazione Russa in cambio all’Ucraina il passaggio al Mar Nero. Tutti i gli Ucraini dichiarino il proprio Stato smilitarizzato e indipendente, decisione auspicata da Papa Francesco (bandiera bianca), in cambio otterrebbero la garanzia e l’appoggio della sicurezza occidentale (UE) e i fondi per la ricostruzione. Quando finiranno i finanziamenti USA, finirà anche la guerra tra Israele e la Palestina.
L’Italia per aderire al patto di garanzia esterna dell’Ucraina, richieda la forza di controllo UE del Mediterraneo, più volte sollecitata da Antonio Tajani. La brama di potere dell’Islam: la ‘’mela rossa’’, in turco ‘’Kizil Alma’’, rappresenta una sorta di mito di frontiera: essa simboleggia il fine ultimo dell’espansione del popolo di Maometto, il luogo fatale che, una volta conquistato, conferirebbe ai musulmani il dominio universale sul globo terracqueo.
…cosa pensa la maggioranza dei cittadini europei….
Il proposito è buono, ma i cittadini europei hanno conoscenze e cultura idonee per esprimere una valutazione?
Forse la famosa “emergenza educativa” andrebbe considerata.
Analisi realistica, ma la rinuncia ad ogni riferimento al rispetto del diritto internazionale appare affidare i destini del pianeta solo a criteri di forza militare. Homo homini lupus. Prospettiva non gradevole che porta con sé l’esigenza di armarsi per non soccombere.
Analisi lucida come sempre tuttavia mi chiedo come mai nonostante la stragrande maggioranza degli italiani sia contro la guerra è pensi che l’Ucraina dal colpo di stato del 2014 abbia molte colpe, il PD, ovvero il partito guerrafondaio e russofobo ad oltranza, goda ancora di così grande credito. Merito di una classe giornalistica schierata alle follie di Brussels ed ai proclami di Zelensky. Una classe che tace anche oggi che è stato arrestato il principale artefice del sabotaggio del gasdotto Nord Stream, guarda caso un ucraino ex militare delle forze speciali! Tra l’altro arrestato proprio in Italia. Prevedo tempi bui per l’Europa è la prospettiva di riportare a casa molte bare dal Donbass di nostri militari non è così lontana. Evidentemente la campagna di Russia è conseguente tragica ritirata degli Alpini nel Don non ha insegnato nulla.
Concordo appieno con le valutazioni (ipotetiche ma lucide) di Ladetto circa le ragioni profonde che muoverebbero il vanesio bellicismo europeo dei c. d. volenterosi, e dei loro più o meno consenzienti accoliti, desiderosi di cercare di non apparire per quello che in realtà sono, cioè delle assolute nullità politiche.
Mi sembra di vedere nell’odierna Europa politicamente divisa (come dissi in altre occasioni la UE mi smbra, al di la delle velleità, non un centro capace di politica ma solo di essere un semplice “ircocervo anarcocapitalistico”) un’istituzione asservita, per necessità di facciata coprenti la loro nullità politica davanti al pur traballante potere imperiale USA.
Infatti gli USA, a loro volta, sono figli dell’impostazione anarcocapitalistica da cui nasce la pretesa di dominare in toto il mondo, prima che con la sovranità della politica statale, mediante quella delle sue potenti croorations, esse stesse detentrici di sovranità di fatto all’interno del loro stesso paese. E in un tale quadro hanno preteso (ingenuamente) di forgiare il mondo a loro immagine e somiglianza.
Agendo con tali presupposti gli USA hanno ritenuto, benché il crollo dell’URSS non sia stato di certo causato da un sconfitta politica e militare della stessa, ma piuttosto favorite da subdole azioni USA (ovviamente favorite dall’odio generalmente sentito dalle popolazioni dell’Europa ex comunista nei confronti dei Russi, non certo imperialmente teneri), di estendere nell’est europeo il loro dominio, giocando in un clima pseudodistensivo nei confronti della Russia postcomunista. E questo, nella sua ipocrisia, non poteva che sfociare nella violenza del putinismo, ora diventato degno compare di merende del violento trumpismo statunitense).
Forse le cose si sarebbero svolte in modo meno periglioso per gli equilibri mondiali se, invece di giocare all”avvociaticchio di Provincia” su chi è stato l’aggressore e chi è stato l’aggredito, la grande dominatrice dell’Occidentale avesse realisticamente accettato sin dall’inizio un mondo policentrico senza illudersi di essere in grado di “materialisticamente redimerlo”, per possederlo integralmente mediante la (declinante anch’essa) american way of life. E ciò in barba alla sua responsabilità di grande potenza che gli imponeva di agire con correttezza rispettando un equilibrato “principio di realtà” che certamente avrebbe distolto meglio l’umanità dai conflitti.
E forse noi occidentali dovremmo imparare che non necessariamente le democrazie sono sempre foriere di pace e tolleranza.
Concluderei osservando che la storia dell’Europa odierna, immersa nel mondo postglobale, mi ricorda molto la crisi in cui cadde l’Italia alla fine del XV Secolo nell’ambito europeo e panmediterraneo: una seria di staterelli fuori misura (globale) economica e politica che giocavano al “Francia o Spagna purché se magna”, naturalmente, all’occorrenza, facendo il “ruggito del topo” minacciando di “suonare le proprie campane” contro le squillanti avversarie trombe, dietro alle quali ci stava una potenza politico-militare di fronte alla quale essi non erano certo in grado di resistere. Anche allora fu tentata in extremis una sorta di UNIONE ITALIANA, simile in qualche modo all’attuale UE (le varie corti italiane erano per lo più imparentate tra di loro), dove ogni stato associato però pensava solo ai propri affari di bottega, per cacciare il francese Carlo VIII, che, al momento, riuscì. Ma il seguito sappiamo tutti come è andato a finire.
Ho la percezione che anche oggi l’l’Europa, come nel XV Secolo l’Italia, abbia perso il senso della realtà.
Analisi molto chiara che indica i rischi di sicurezza ai quali ci espone la linea dei Paesi “volenterosi”. Infatti, la pace è possibile solo se, come osserva Ladetto, si tiene conto delle ragioni addotte da ciascuna delle due parti. L’Ue, a rimorchio del Regno Unito, sinora ha dato l’impressione di puntare al massimo a una tregua armata, e di non fare sino in fondo la sua parte nella costruzione di un nuovo sistema di sicurezza in Europa, accettabile per l’Ovest e per l’Est.