
Storicismo e post storicismo non sono solo due correnti di pensiero riguardanti la comunità degli studiosi di storia e le accademie; contrassegnano una linea di frattura fra nazioni, popoli, Stati e, all’interno di questi ultimi (prevalentemente in Occidente), dividono l’opinione pubblica e contrappongono i partiti politici. È una linea di frattura che si sovrappone ad altre discriminanti e/o si intreccia con esse: fra liberalismo e populismo, fra sovranità degli Stati e globalizzazione, fra cosmopolitismo e identità nazionale. Visto che di storicismo e post storicismo si parla sempre più frequentemente, in specie in ambito geopolitico, ho cercato di fare chiarezza in materia, innanzi tutto a me stesso.
È a tutti noto il saggio di Francis Fukuyama riguardante la fine della Storia. In tale scritto, l’autore, constatando che, nel corso del Novecento, erano falliti tutti i tentativi di edificare progetti politico-sociali alternativi al liberalismo, dichiara che in un futuro prossimo non ci sarà più spazio per percorsi differenti dalla liberaldemocrazia. Sotto la guida degli Stati Uniti (la potenza che ha sconfitto fascismo e comunismo), si diffonderanno in tutto il pianeta, con la globalizzazione, le istituzioni liberaldemocratiche e le modalità economiche e produttive proprie del moderno capitalismo, unitamente ai modi di vita che caratterizzano i Paesi occidentali. Pertanto, non avremo più guerre, e, scomparsi i confini, omologate le culture a quella dominante del Paese guida, ci si potrà dimenticare del passato e vivere in un presente in cui sarà il solo approccio mercantilistico ad informare le mosse della società, essendo la condizione economicistica lo stadio ultimo di ogni percorso politico.
Per ora, le cose non sono andate così, ma i post storicisti, pur riconoscendo che il percorso sia più difficile del previsto, restano convinti che comunque la sua direzione non potrà essere diversa da quanto annunciato, e che pertanto si giungerà comunque alla fine della Storia.
Anche per l’élite ai vertici della UE, l’auspicata unione non è una costruzione che ha il suo radicamento e la sua giustificazione in una storia comune e in una cultura largamente condivisa, ma non sarebbe altro che una tappa in vista della realizzazione di una società mondiale omologata, costruita all'insegna della logica di mercato e dei diritti dell'uomo.
Tuttavia, anche per i post storicisti, la Storia, al presente, esiste ancora, ma unicamente quella universale scritta con la maiuscola, riconducibile al pensiero illuministico, per il quale la società e l’umanità intera procedono su un cammino di continuo progresso, frutto della ragione, della scienza e della tecnica, strumenti capaci di abbattere ogni ostacolo, di sradicare ogni superstizione e mito. Si tratta di un percorso predeterminato al cui termine, in un mondo omologato con la piena affermazione dei valori dei lumi, ereditati dall’Occidente, la Storia avrà raggiunto il suo ultimo traguardo, e, a questo stadio, si farà da parte.
In quest’ottica, recentemente, a proposito della guerra in Ucraina, è stato più volte detto che la Russia è rimasta indietro nella Storia, ancorata a una concezione del secolo scorso che pone ancora al centro della propria attenzione la sua potenza di nazione.
Ma ci dice Dario Fabbri (direttore di “Domino”, rivista di geopolitica) che la sopracitata Storia (con la maiuscola) non esiste; ci sono invece le tante storie riguardanti eventi di territori e popoli in cui ogni collettività narra il suo passato sulla base della propria memoria dei fatti e secondo le proprie preferenze e i propri interessi.
Così, in varie aree del mondo, si è manifestata la volontà di continuare a vivere nella storia (la propria storia). Sono in particolare i Paesi del cosiddetto “Mondo contro” a respingere l’omologazione e a voler restare ancorati al lascito del proprio passato, alla propria cultura, componenti essenziali della propria identità di popolo, di nazione. Un sentimento particolarmente marcato in quei Paesi che hanno vissuto come un risorgimento nazionale la lotta di liberazione dal colonialismo.
Tuttavia, il rigetto di una Storia universale destinata presto a estinguersi riguarda tutti i popoli, perché la cancellazione o la dimenticanza del passato ci conduce a non sapere più chi siamo, da dove veniamo, a chi siamo legati da vincoli di solidarietà e con cui intendiamo progettare il futuro. In pratica, si dissolve ogni sentimento di appartenenza a qualche cosa per cui battersi e impegnarsi, che sia la nazione o la comunità o la famiglia. Ne è manifestazione l’individualismo estremo che caratterizza i Paesi in cui si è imposto il post storicismo (ovvero il venir meno del collegamento tra passato e futuro).
A quali cause e responsabilità, le due contrapposte scuole di pensiero fanno risalire quella guerra mondiale a pezzi che già alcuni anni fa denunciava papa Francesco, una guerra che oggi si estende e minaccia di sfuggire ad ogni controllo?
Per una parte (i post storicisti), ogni responsabilità viene attribuita a chi è rimasto ancorato al passato, alla propria storia, una dimensione dove regnano i sentimenti, sovente negativi, vi comandano le passioni, dominano la brama di potere, una volontà manifesta di sottomettere l’altro, e la paura di essere attaccati e quindi la necessità di attaccare. È una visione della storia in cui non c’è spazio per temi altissimi quali i diritti umani, l’ambientalismo, il femminismo, l’inclusione di chi rivendica il riconoscimento della propria diversità, ma si impongono il buio, le tenebre, i sacrifici e le sofferenze.
Sull’altro fronte (gli storicisti), si denuncia il carattere illusorio, fuori della realtà, di una rappresentazione nella quale, aboliti gli Stati nazionali, scomparsi i confini, omologate le culture, divenuto universale il modello liberaldemocratico, ne conseguirebbero la pace universale, la collaborazione tra i vari territori del pianeta, e la piena affermazione dei diritti individuali.
Ci dicono, infatti, affermati cultori di geopolitica (Lucio Caracciolo e John Mearsheimer) che la condivisione del sistema istituzionale non evita la competizione e il conflitto fra gli Stati, mentre non basta la diffusione della democrazia per garantire un futuro di pace, e neppure bastano la libera circolazione dei prodotti e dei capitali e l’interdipendenza delle economie..
Secondo Henry Kissinger, poiché gli organismi internazionali non sono in grado di dirimere i conflitti, la migliore garanzia per una pace stabile resta la ricerca di un nuovo equilibrio globale tra le varie potenze (aventi storie, culture, valori e istituzioni differenti), una ricerca capace di sciogliere i molteplici nodi alla base dei conflitti e di dare vita ad un insieme di regole condivise, fondate sul reciproco riconoscimento e rispetto.
La geopolitica (ci ha spiegato Lucio Caracciolo), analizzando i conflitti di potere, si avvale di competenze e discipline diverse, ma ad aver maggior peso è soprattutto la storia, perché gli attori politici ricorrono alla storia (come da loro interpretata) per confermare il proprio status e i connessi progetti territoriali, e per legittimare se stessi e le proprie azioni. Non deve pertanto stupire che chi si occupa di geopolitica giudichi negativamente le rappresentazioni degli eventi descritte dai post storicisti.
Infatti, Dario Fabbri scrive che, nel tempo attuale, non mancano crisi più o meno cruente, mentre altre stanno per proporsi. Pertanto, occorre comprendere dove conduca il nostro vivere fuori dal tempo. L’inettitudine nello spiegare cosa accade nel pianeta ci viene dall’aver creduta vera la fine della storia, dall’aver smesso di studiarla, preferendo soffermarsi a discettare di leader, ideologie e giurisprudenze, ovvero di tutto ciò che non conta. La misconoscenza della storia ci procura impazzimento.
Il ricorso alle argomentazioni di queste due contrapposte scuole di pensiero ci facilita la comprensione di quanto sta accadendo con un rinato bellicismo e un vera e propria diffusa perdita di autocontrollo di chi è al potere?
Solo in una qualche misura perché, a ben vedere, alla base degli odierni eventi negativi, c’è soprattutto il contrasto tra l’Occidente (che identifica se stesso nella democrazia) e il Non Occidente ovvero il Mondo contro (certo illiberale, ma non sempre descrivibile come autocratico, o dittatoriale). Ma se quest’ultimo è sicuramente storicista, non tutto l’Occidente è post storicista.
Lo è certo, da oltre 70 anni, quell’Europa occidentale complessivamente uscita a pezzi dalla Seconda guerra mondiale, e che, pertanto, ha accantonato ogni serio impegno internazionale e la stessa sua difesa, per dedicarsi esclusivamente all’economia e alla ricerca del benessere. Solo oggi, resasi conto di non contare più nulla, cerca di darsi una credibilità ricorrendo ad un riarmo spropositato (il 5% del PIL), difficilmente sostenibile.
Invece, gli Stati Uniti, a parole, si rivelano post storicisti in taluni atteggiamenti della componente liberal (che nel movimento wokista raggiunge un livello estremo), ma, nei fatti, chiunque guidi il Paese, si comportano sempre secondo i dettami della realpolitik, alla cui base ci sono considerazioni di sicurezza e obiettivi di potenza.
Credo, pertanto, che le cause dell’impazzimento generale e dell’imperante bellicismo siano molteplici, ma certamente concepire ideologicamente ogni confronto e ogni contesa in termini di lotta tra il Bene e il Male è sicuramente incompatibile con un mondo pacificato.
È a tutti noto il saggio di Francis Fukuyama riguardante la fine della Storia. In tale scritto, l’autore, constatando che, nel corso del Novecento, erano falliti tutti i tentativi di edificare progetti politico-sociali alternativi al liberalismo, dichiara che in un futuro prossimo non ci sarà più spazio per percorsi differenti dalla liberaldemocrazia. Sotto la guida degli Stati Uniti (la potenza che ha sconfitto fascismo e comunismo), si diffonderanno in tutto il pianeta, con la globalizzazione, le istituzioni liberaldemocratiche e le modalità economiche e produttive proprie del moderno capitalismo, unitamente ai modi di vita che caratterizzano i Paesi occidentali. Pertanto, non avremo più guerre, e, scomparsi i confini, omologate le culture a quella dominante del Paese guida, ci si potrà dimenticare del passato e vivere in un presente in cui sarà il solo approccio mercantilistico ad informare le mosse della società, essendo la condizione economicistica lo stadio ultimo di ogni percorso politico.
Per ora, le cose non sono andate così, ma i post storicisti, pur riconoscendo che il percorso sia più difficile del previsto, restano convinti che comunque la sua direzione non potrà essere diversa da quanto annunciato, e che pertanto si giungerà comunque alla fine della Storia.
Anche per l’élite ai vertici della UE, l’auspicata unione non è una costruzione che ha il suo radicamento e la sua giustificazione in una storia comune e in una cultura largamente condivisa, ma non sarebbe altro che una tappa in vista della realizzazione di una società mondiale omologata, costruita all'insegna della logica di mercato e dei diritti dell'uomo.
Tuttavia, anche per i post storicisti, la Storia, al presente, esiste ancora, ma unicamente quella universale scritta con la maiuscola, riconducibile al pensiero illuministico, per il quale la società e l’umanità intera procedono su un cammino di continuo progresso, frutto della ragione, della scienza e della tecnica, strumenti capaci di abbattere ogni ostacolo, di sradicare ogni superstizione e mito. Si tratta di un percorso predeterminato al cui termine, in un mondo omologato con la piena affermazione dei valori dei lumi, ereditati dall’Occidente, la Storia avrà raggiunto il suo ultimo traguardo, e, a questo stadio, si farà da parte.
In quest’ottica, recentemente, a proposito della guerra in Ucraina, è stato più volte detto che la Russia è rimasta indietro nella Storia, ancorata a una concezione del secolo scorso che pone ancora al centro della propria attenzione la sua potenza di nazione.
Ma ci dice Dario Fabbri (direttore di “Domino”, rivista di geopolitica) che la sopracitata Storia (con la maiuscola) non esiste; ci sono invece le tante storie riguardanti eventi di territori e popoli in cui ogni collettività narra il suo passato sulla base della propria memoria dei fatti e secondo le proprie preferenze e i propri interessi.
Così, in varie aree del mondo, si è manifestata la volontà di continuare a vivere nella storia (la propria storia). Sono in particolare i Paesi del cosiddetto “Mondo contro” a respingere l’omologazione e a voler restare ancorati al lascito del proprio passato, alla propria cultura, componenti essenziali della propria identità di popolo, di nazione. Un sentimento particolarmente marcato in quei Paesi che hanno vissuto come un risorgimento nazionale la lotta di liberazione dal colonialismo.
Tuttavia, il rigetto di una Storia universale destinata presto a estinguersi riguarda tutti i popoli, perché la cancellazione o la dimenticanza del passato ci conduce a non sapere più chi siamo, da dove veniamo, a chi siamo legati da vincoli di solidarietà e con cui intendiamo progettare il futuro. In pratica, si dissolve ogni sentimento di appartenenza a qualche cosa per cui battersi e impegnarsi, che sia la nazione o la comunità o la famiglia. Ne è manifestazione l’individualismo estremo che caratterizza i Paesi in cui si è imposto il post storicismo (ovvero il venir meno del collegamento tra passato e futuro).
A quali cause e responsabilità, le due contrapposte scuole di pensiero fanno risalire quella guerra mondiale a pezzi che già alcuni anni fa denunciava papa Francesco, una guerra che oggi si estende e minaccia di sfuggire ad ogni controllo?
Per una parte (i post storicisti), ogni responsabilità viene attribuita a chi è rimasto ancorato al passato, alla propria storia, una dimensione dove regnano i sentimenti, sovente negativi, vi comandano le passioni, dominano la brama di potere, una volontà manifesta di sottomettere l’altro, e la paura di essere attaccati e quindi la necessità di attaccare. È una visione della storia in cui non c’è spazio per temi altissimi quali i diritti umani, l’ambientalismo, il femminismo, l’inclusione di chi rivendica il riconoscimento della propria diversità, ma si impongono il buio, le tenebre, i sacrifici e le sofferenze.
Sull’altro fronte (gli storicisti), si denuncia il carattere illusorio, fuori della realtà, di una rappresentazione nella quale, aboliti gli Stati nazionali, scomparsi i confini, omologate le culture, divenuto universale il modello liberaldemocratico, ne conseguirebbero la pace universale, la collaborazione tra i vari territori del pianeta, e la piena affermazione dei diritti individuali.
Ci dicono, infatti, affermati cultori di geopolitica (Lucio Caracciolo e John Mearsheimer) che la condivisione del sistema istituzionale non evita la competizione e il conflitto fra gli Stati, mentre non basta la diffusione della democrazia per garantire un futuro di pace, e neppure bastano la libera circolazione dei prodotti e dei capitali e l’interdipendenza delle economie..
Secondo Henry Kissinger, poiché gli organismi internazionali non sono in grado di dirimere i conflitti, la migliore garanzia per una pace stabile resta la ricerca di un nuovo equilibrio globale tra le varie potenze (aventi storie, culture, valori e istituzioni differenti), una ricerca capace di sciogliere i molteplici nodi alla base dei conflitti e di dare vita ad un insieme di regole condivise, fondate sul reciproco riconoscimento e rispetto.
La geopolitica (ci ha spiegato Lucio Caracciolo), analizzando i conflitti di potere, si avvale di competenze e discipline diverse, ma ad aver maggior peso è soprattutto la storia, perché gli attori politici ricorrono alla storia (come da loro interpretata) per confermare il proprio status e i connessi progetti territoriali, e per legittimare se stessi e le proprie azioni. Non deve pertanto stupire che chi si occupa di geopolitica giudichi negativamente le rappresentazioni degli eventi descritte dai post storicisti.
Infatti, Dario Fabbri scrive che, nel tempo attuale, non mancano crisi più o meno cruente, mentre altre stanno per proporsi. Pertanto, occorre comprendere dove conduca il nostro vivere fuori dal tempo. L’inettitudine nello spiegare cosa accade nel pianeta ci viene dall’aver creduta vera la fine della storia, dall’aver smesso di studiarla, preferendo soffermarsi a discettare di leader, ideologie e giurisprudenze, ovvero di tutto ciò che non conta. La misconoscenza della storia ci procura impazzimento.
Il ricorso alle argomentazioni di queste due contrapposte scuole di pensiero ci facilita la comprensione di quanto sta accadendo con un rinato bellicismo e un vera e propria diffusa perdita di autocontrollo di chi è al potere?
Solo in una qualche misura perché, a ben vedere, alla base degli odierni eventi negativi, c’è soprattutto il contrasto tra l’Occidente (che identifica se stesso nella democrazia) e il Non Occidente ovvero il Mondo contro (certo illiberale, ma non sempre descrivibile come autocratico, o dittatoriale). Ma se quest’ultimo è sicuramente storicista, non tutto l’Occidente è post storicista.
Lo è certo, da oltre 70 anni, quell’Europa occidentale complessivamente uscita a pezzi dalla Seconda guerra mondiale, e che, pertanto, ha accantonato ogni serio impegno internazionale e la stessa sua difesa, per dedicarsi esclusivamente all’economia e alla ricerca del benessere. Solo oggi, resasi conto di non contare più nulla, cerca di darsi una credibilità ricorrendo ad un riarmo spropositato (il 5% del PIL), difficilmente sostenibile.
Invece, gli Stati Uniti, a parole, si rivelano post storicisti in taluni atteggiamenti della componente liberal (che nel movimento wokista raggiunge un livello estremo), ma, nei fatti, chiunque guidi il Paese, si comportano sempre secondo i dettami della realpolitik, alla cui base ci sono considerazioni di sicurezza e obiettivi di potenza.
Credo, pertanto, che le cause dell’impazzimento generale e dell’imperante bellicismo siano molteplici, ma certamente concepire ideologicamente ogni confronto e ogni contesa in termini di lotta tra il Bene e il Male è sicuramente incompatibile con un mondo pacificato.
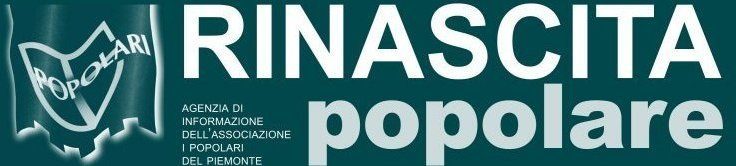
Io propongo una diversa ipotesi, che mi riservo di argomentare in prosieguo, essendo per ora una provocazione al dibattito.
La capacita’di regolare i fenomeni di portata transnazionale o globale (cambiamenti climatico-ambientali, migrazioni, regolazione dei mercati digitali) e’ sfuggita dalle possibilita’ efficaci dell’istituzione “nazione” nata nel XVIIsecolo in Francia (mito della sovranita’ popolare, democrazia parlamentare,controllo del comportamento sociale tramite il “diritto statuale” ecc.).
Viene gradatamente, ma efficientemente sostituita dall’azione delle grandi imprese transnazionali (senza nazione di riferimento, ma in cerca della nazione piu’ favorevole).
E’ gia’ avvenuto nella storia: si pensi alla Compagnia olandese delle Indie Orientali, che ricevette,per sviluppare la sua potenza colonizzatrice, il diritto di fare trattati, armare un esercito, regolare i rapporti con gli staterelli (fare diritto).
Quale può essere, sul piano delle istituzioni il quadro normativo? Un federalismo interno (tra business units) e esterno (tra dirigenze transnazionali per regole condivise). Occorrera’ percio’ formare le dirigenze ad altri valori che il semplice profitto o il potere manageriale; valori come la cooperazione, la sostenibilita’, l’approccio coevolutivo con i meno resilienti,
Discutere e professare ora questi valori, non piu’ a livello ” nazionale” ma a livello impresotransnazionale permettera’ ai cittadini implicati nel processo economico di arrivare preparati.