
C’è un film del 1973, “Il delitto Matteotti” di Florestano Vancini, in cui – richiesto dal direttore de “Il Popolo” Giuseppe Donati di “dirgli qualche cosa” a poche ore dalla sua partenza per l’esilio – don Sturzo replica: “Chi parte non ha consigli da dare a chi resta. Che Dio vi protegga tutti”.
Dato il titolo pericolosissimo di questo mio intervento, salvo alcuni dati incontrovertibili a cui farò riferimento, è la frase più onesta che mi sia riuscito di trovare per non mettere in bocca a Sturzo, o a qualche altro illustre padre politico, parole non sue.
Al contrario, mi pare molto più necessario, e impegnativo, sentirmi interrogare in prima persona da lui e da quegli altri illustri padri di cui sopra: “Non io, che sono partito, ma voi che restate, cosa dite di voi stessi?”. In altre parole: se la politica è l’arte di leggere il presente per inventare il futuro, state praticando quell’arte o un’altra che si chiama nostalgia per il passato? Se è vera la seconda opzione, possiamo già andare a casa. Se è vera la prima, da parte mia ecco pochi spunti di riflessione, forse ovvi, forse talmente ovvi che è il caso di ridirli.
1) Noi stiamo vivendo prigionieri di una grande contraddizione, nata ai tempi di Tangentopoli e non ancora risolta. Allora, prendendo atto di quel fallimento, morale prima ancora che politico, Giuseppe Dossetti invitò i cattolici – ma in un’ottica di laicità, pluralismo e anche solo di semplice lettura della realtà, l’invito era ed è aperto a tutti – a ricominciare a prepararsi e farlo per i vent’anni a seguire. Se l’avessimo ascoltato, oggi avremmo la classe dirigente di 40-60enni che ci manca, il primo, vero e gigantesco problema che questo paese ha oggi. Si scelse un’altra strada (senza polemiche: quella di Ruini) la cui bontà possiamo oggi evangelicamente giudicare alla luce dei frutti che ha prodotto. Ed ecco la nostra contraddizione: da un lato l’esigenza assoluta di creare una classe dirigente, dall’altro la mancanza assoluta di tempo per farlo.
2) Dunque, come possiamo abitare dentro questa contraddizione e i tempi a cui ci obbliga? Sognando terze primavere, dimenticando che quelle del 1919 o del 1948 si forgiarono negli inverni dei venti o trent’anni precedenti, ivi comprese due guerre mondiali? Con operazioni a tavolino, che vogliono i frutti senza preparare le condizioni politiche, sociali (e mi permetto: spirituali e di pensiero) per farli maturare? O promuovendo partitini che durerebbero lo spazio d’un mattino, rivelandosi un’operazione suicida che farebbe la fortuna, l’ennesima, di quei falsi profeti, in felpa o non in felpa, che esibiscono vangeli che non venerano? Lasciatemi citare il mio vescovo Matteo Zuppi: saremmo all’accanimento terapeutico. E anche me stesso: il partito identitario non lo fece Sturzo nel 1919 e dovremmo farlo noi oggi?
Oppure, all’opposto, continuare a limitarsi a operazioni prepolitiche, lodevoli, necessarie, ma, sempre alla luce dei dati di realtà dell’ultimo quarto di secolo – alla fin fine non sufficienti, e non voglio dire irrilevanti o afone?
3) Forse, per usare le parole di Francesco Luigi Ferrari, chi oggi intende gettare “un seme di sana democrazia” potrebbe tentare di muoversi in maniera nuova tra queste due vie. Forse, come spiega un altro Francesco, il papa, non occupando spazi – al centro o non al centro non è il punto, basta che la parola centro non si accompagni all’aggettivo, “moderato”, che personalmente mi repelle anche solo pronunciare, preferendo l’aggettivo “radicale”, di radicalismo evangelico – ma di avviare processi; anche perché è avviando processi che gli spazi si aprono.
Quali spazi? Quelli che vanno cercati nel mondo di oggi. Se c’è un'altra cosa che ci avvicina a Sturzo è il vivere una fase storica di transizione, anzi un cambio di sistema, anzi un cambio d’epoca, che mette fine – detto con Stefan Zweig – al mondo di ieri. Il mondo di ieri, per quanto potesse piacerci, resterà di ieri. Quello di oggi parla di nuovi attori globali, del peso devastante delle crisi economiche, degli effetti della rivoluzione tecnologica, degli sconvolgimenti del mercato del lavoro, dello svuotamento dello stato sociale, dell’impoverimento di milioni di cittadini, dei flussi migratori, dell’emergenza climatica. E nessuno può più nascondersi che su questi temi si sono prodotte le grandi menzogne populiste. Ne dico una a caso: “venticinque anni fa non c’era l’Europa, venticinque anni fa stavamo meglio, dunque la colpa di tutto è dell’Europa”. Falso? Sì. Ma slogan vincente perché vissuto come vero, e con vere conseguenze, da tutti coloro che, sentendosi vittime d’ingiustizia, non avendo avuto giustizia hanno finito per affidarsi ai giustizieri. Quelli della finta onestà e quelli del vero far west.
E dunque? E dunque è qui, non in un altrove, che credo possa essere tentato un percorso comune, per tappe, fuggendo la logica di chi crede di poter dare risposta a tutto, secondo il “ghe pensi mi” di non venerata memoria. Una risposta, e siamo a Sturzo per la terza volta, di programma.
Il “cosa” di questo percorso l’ho già accennato, perché è l’agenda politica stessa a dettarlo; fermo restando che se uno ha un disegno politico e la sapienza, o – con Aldo Moro – l’intelligenza degli avvenimenti, l’agenda politica può dettarla invece di doverla subire: l’idea che l’interesse dell’Europa è interesse nazionale; che la democrazia non funziona a colpi di diritti individuali ma anche sociali, compresi – ne dico due – quello al lavoro che non c’è, o alla cura dell’ambiente; che questi diritti si concertano; e che non sono solo quelli dei pensionati, ma anche delle generazioni che vengono dopo – la mia, che è messa male, e quella dopo la mia, che è messa peggio – da cui ci divide un abisso, con cui è stato frantumato un patto che va rifatto. Possibilmente entro ieri.
Perché lo dico? Perché, insieme al “che cosa”, c’è un “chi” altrettanto importante. Liberi, d’accordo, forti, pure d’accordo, e anche giovani? Non ho simpatie per le rottamazioni e neppure ritengo che “gioventù” e “competenza” siano sinonimi; ma vivaddio passa la scena di questo mondo e richiede di far spazio a chi non ha conosciuto il mondo di ieri, ma solo quello di oggi; a chi non ha conosciuto lo sviluppo della democrazia ma solo la sua crisi. Riusciamo ad ascoltarne le domande o solo a farceli scappare proprio tutti? Siamo sicuri che non abbiano nuove competenze o modi d’aggregazione da suggerirci? E per nostro conto, che orizzonte di senso siamo in grado di indicare loro?
Ed eccoci al come. “Come” si intercettano le loro domande, come si intercettano le domande, anche inespresse, di quel 50% di elettori non votanti che (non mi addentro nelle cause) considera irricevibili le presenti proposte politiche? Che risposte diamo, non a loro, ma con loro?
Facendo opere. Facendo rete. Facendo politica con le opere messe in rete. Qualunque cosa sia, tutto il resto – che Shakespeare mi perdoni, se non vogliamo che sia silenzio – verrà dopo. Esiste ancora una società civile che, direbbe Lapalisse, specchia ed è specchio di quella politica? In profonda mutazione, ma certo che esiste. Ed è politicamente organizzata? Certo che no. Lo sappiamo: i corpi intermedi non ci sono più, l’associazionismo si è indebolito e via con tutta la litania. Forse però conosciamo molto meno bene le nuove forme che sta assumendo. Conosco personalmente, come ciascuno di voi conoscerà, realtà di buona amministrazione pubblica, scuole di formazione politica, associazioni nate intorno ai temi dell’etica ambientale e all’etica della rete, progetti di economia sociale e imprenditoria solidale, e associazioni nascenti da cui viene una domanda politica.
È possibile pensare a una casa, a un luogo in cui tutti costoro si possano incontrare e confrontare sui contenuti? È possibile, alla fine, pensare ad aggregare il frutto del confronto in una proposta unitaria di livello nazionale aperta a tutti coloro che la condividono?
Sono le due domande aperte, sulle quali chiudo questo intervento, forse pieno di cose ovvie e forse anche poco concrete. Farina del mio sacco che – salvo i riferimenti necessari – non mi sento di mettere in bocca a Sturzo. Anche se ho cercato di averlo in mente in questo tentativo di dare una prospettiva politica all’urgenza d’una reazione morale alla barbarie, ai toni e alle parole d’ordine (anzi di dis-ordine) urlati oggi dalle voci più squallide. Quelle dei “mestieranti” – queste sì, parole di don Luigi – che fasce sempre più larghe di società si stanno scegliendo per beniamini.
E da questo Dio scampi e liberi i forti e i meno forti.
Dato il titolo pericolosissimo di questo mio intervento, salvo alcuni dati incontrovertibili a cui farò riferimento, è la frase più onesta che mi sia riuscito di trovare per non mettere in bocca a Sturzo, o a qualche altro illustre padre politico, parole non sue.
Al contrario, mi pare molto più necessario, e impegnativo, sentirmi interrogare in prima persona da lui e da quegli altri illustri padri di cui sopra: “Non io, che sono partito, ma voi che restate, cosa dite di voi stessi?”. In altre parole: se la politica è l’arte di leggere il presente per inventare il futuro, state praticando quell’arte o un’altra che si chiama nostalgia per il passato? Se è vera la seconda opzione, possiamo già andare a casa. Se è vera la prima, da parte mia ecco pochi spunti di riflessione, forse ovvi, forse talmente ovvi che è il caso di ridirli.
1) Noi stiamo vivendo prigionieri di una grande contraddizione, nata ai tempi di Tangentopoli e non ancora risolta. Allora, prendendo atto di quel fallimento, morale prima ancora che politico, Giuseppe Dossetti invitò i cattolici – ma in un’ottica di laicità, pluralismo e anche solo di semplice lettura della realtà, l’invito era ed è aperto a tutti – a ricominciare a prepararsi e farlo per i vent’anni a seguire. Se l’avessimo ascoltato, oggi avremmo la classe dirigente di 40-60enni che ci manca, il primo, vero e gigantesco problema che questo paese ha oggi. Si scelse un’altra strada (senza polemiche: quella di Ruini) la cui bontà possiamo oggi evangelicamente giudicare alla luce dei frutti che ha prodotto. Ed ecco la nostra contraddizione: da un lato l’esigenza assoluta di creare una classe dirigente, dall’altro la mancanza assoluta di tempo per farlo.
2) Dunque, come possiamo abitare dentro questa contraddizione e i tempi a cui ci obbliga? Sognando terze primavere, dimenticando che quelle del 1919 o del 1948 si forgiarono negli inverni dei venti o trent’anni precedenti, ivi comprese due guerre mondiali? Con operazioni a tavolino, che vogliono i frutti senza preparare le condizioni politiche, sociali (e mi permetto: spirituali e di pensiero) per farli maturare? O promuovendo partitini che durerebbero lo spazio d’un mattino, rivelandosi un’operazione suicida che farebbe la fortuna, l’ennesima, di quei falsi profeti, in felpa o non in felpa, che esibiscono vangeli che non venerano? Lasciatemi citare il mio vescovo Matteo Zuppi: saremmo all’accanimento terapeutico. E anche me stesso: il partito identitario non lo fece Sturzo nel 1919 e dovremmo farlo noi oggi?
Oppure, all’opposto, continuare a limitarsi a operazioni prepolitiche, lodevoli, necessarie, ma, sempre alla luce dei dati di realtà dell’ultimo quarto di secolo – alla fin fine non sufficienti, e non voglio dire irrilevanti o afone?
3) Forse, per usare le parole di Francesco Luigi Ferrari, chi oggi intende gettare “un seme di sana democrazia” potrebbe tentare di muoversi in maniera nuova tra queste due vie. Forse, come spiega un altro Francesco, il papa, non occupando spazi – al centro o non al centro non è il punto, basta che la parola centro non si accompagni all’aggettivo, “moderato”, che personalmente mi repelle anche solo pronunciare, preferendo l’aggettivo “radicale”, di radicalismo evangelico – ma di avviare processi; anche perché è avviando processi che gli spazi si aprono.
Quali spazi? Quelli che vanno cercati nel mondo di oggi. Se c’è un'altra cosa che ci avvicina a Sturzo è il vivere una fase storica di transizione, anzi un cambio di sistema, anzi un cambio d’epoca, che mette fine – detto con Stefan Zweig – al mondo di ieri. Il mondo di ieri, per quanto potesse piacerci, resterà di ieri. Quello di oggi parla di nuovi attori globali, del peso devastante delle crisi economiche, degli effetti della rivoluzione tecnologica, degli sconvolgimenti del mercato del lavoro, dello svuotamento dello stato sociale, dell’impoverimento di milioni di cittadini, dei flussi migratori, dell’emergenza climatica. E nessuno può più nascondersi che su questi temi si sono prodotte le grandi menzogne populiste. Ne dico una a caso: “venticinque anni fa non c’era l’Europa, venticinque anni fa stavamo meglio, dunque la colpa di tutto è dell’Europa”. Falso? Sì. Ma slogan vincente perché vissuto come vero, e con vere conseguenze, da tutti coloro che, sentendosi vittime d’ingiustizia, non avendo avuto giustizia hanno finito per affidarsi ai giustizieri. Quelli della finta onestà e quelli del vero far west.
E dunque? E dunque è qui, non in un altrove, che credo possa essere tentato un percorso comune, per tappe, fuggendo la logica di chi crede di poter dare risposta a tutto, secondo il “ghe pensi mi” di non venerata memoria. Una risposta, e siamo a Sturzo per la terza volta, di programma.
Il “cosa” di questo percorso l’ho già accennato, perché è l’agenda politica stessa a dettarlo; fermo restando che se uno ha un disegno politico e la sapienza, o – con Aldo Moro – l’intelligenza degli avvenimenti, l’agenda politica può dettarla invece di doverla subire: l’idea che l’interesse dell’Europa è interesse nazionale; che la democrazia non funziona a colpi di diritti individuali ma anche sociali, compresi – ne dico due – quello al lavoro che non c’è, o alla cura dell’ambiente; che questi diritti si concertano; e che non sono solo quelli dei pensionati, ma anche delle generazioni che vengono dopo – la mia, che è messa male, e quella dopo la mia, che è messa peggio – da cui ci divide un abisso, con cui è stato frantumato un patto che va rifatto. Possibilmente entro ieri.
Perché lo dico? Perché, insieme al “che cosa”, c’è un “chi” altrettanto importante. Liberi, d’accordo, forti, pure d’accordo, e anche giovani? Non ho simpatie per le rottamazioni e neppure ritengo che “gioventù” e “competenza” siano sinonimi; ma vivaddio passa la scena di questo mondo e richiede di far spazio a chi non ha conosciuto il mondo di ieri, ma solo quello di oggi; a chi non ha conosciuto lo sviluppo della democrazia ma solo la sua crisi. Riusciamo ad ascoltarne le domande o solo a farceli scappare proprio tutti? Siamo sicuri che non abbiano nuove competenze o modi d’aggregazione da suggerirci? E per nostro conto, che orizzonte di senso siamo in grado di indicare loro?
Ed eccoci al come. “Come” si intercettano le loro domande, come si intercettano le domande, anche inespresse, di quel 50% di elettori non votanti che (non mi addentro nelle cause) considera irricevibili le presenti proposte politiche? Che risposte diamo, non a loro, ma con loro?
Facendo opere. Facendo rete. Facendo politica con le opere messe in rete. Qualunque cosa sia, tutto il resto – che Shakespeare mi perdoni, se non vogliamo che sia silenzio – verrà dopo. Esiste ancora una società civile che, direbbe Lapalisse, specchia ed è specchio di quella politica? In profonda mutazione, ma certo che esiste. Ed è politicamente organizzata? Certo che no. Lo sappiamo: i corpi intermedi non ci sono più, l’associazionismo si è indebolito e via con tutta la litania. Forse però conosciamo molto meno bene le nuove forme che sta assumendo. Conosco personalmente, come ciascuno di voi conoscerà, realtà di buona amministrazione pubblica, scuole di formazione politica, associazioni nate intorno ai temi dell’etica ambientale e all’etica della rete, progetti di economia sociale e imprenditoria solidale, e associazioni nascenti da cui viene una domanda politica.
È possibile pensare a una casa, a un luogo in cui tutti costoro si possano incontrare e confrontare sui contenuti? È possibile, alla fine, pensare ad aggregare il frutto del confronto in una proposta unitaria di livello nazionale aperta a tutti coloro che la condividono?
Sono le due domande aperte, sulle quali chiudo questo intervento, forse pieno di cose ovvie e forse anche poco concrete. Farina del mio sacco che – salvo i riferimenti necessari – non mi sento di mettere in bocca a Sturzo. Anche se ho cercato di averlo in mente in questo tentativo di dare una prospettiva politica all’urgenza d’una reazione morale alla barbarie, ai toni e alle parole d’ordine (anzi di dis-ordine) urlati oggi dalle voci più squallide. Quelle dei “mestieranti” – queste sì, parole di don Luigi – che fasce sempre più larghe di società si stanno scegliendo per beniamini.
E da questo Dio scampi e liberi i forti e i meno forti.
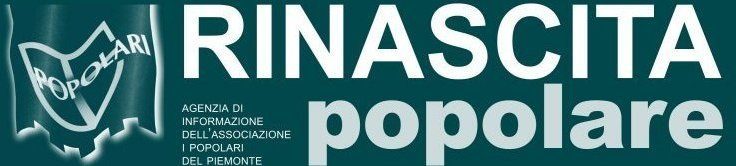
Sono un nonno che ha sempre votato D.C. e poi P.D. Lei ha “ridetto”: fare rete – una casa. La rete è composta di tanti legami. Un esempio: nelle sezioni locali si dialoga tra eletti ed elettori, una sintesi periodica va al Provinciale, poi al Regionale, poi al Nazionale, poi una sintesi torna alla sezione locale. Questa è una RETE?
Gentilissimo cav. Moriotti, lei ha assolutamente ragione.
Analisi molto pertinente. Abbiamo bisogno di chi pensa e propone e non di narcisi che sbraitano. La politica parla di noi e non dei capricci della classe dirigente (?!) O dei retroscena sempre più fantasiosi quanto mutevoli… la politica è occuparsi di tutti (l’ormai dimenticato popolo rimpiazzato dalla rete del web). Quanto abbiamo bisogno di una rinascita popolare!
Sottoscrivo.