
Ancora oggi, ci sono quanti continuano a negare la realtà delle modificazioni climatiche, o tendono a minimizzarne la portata definendole una mera ipotesi da verificare, o collocandole in un lontano futuro. Fra questi, in particolare, ci sono molti cultori di economia e operatori del mondo produttivo. A sostegno di tale opinione, vengono citati taluni fisici, statistici e matematici che manifestano perplessità in proposito o che non riconoscono la natura antropica del fenomeno. Eppure la quasi totalità dei climatologi, certamente i ricercatori più qualificati a esprimere valutazioni pertinenti, non ha dubbi in materia e manifesta viva preoccupazione per l'inerzia con cui la minaccia viene affrontata da chi ha in mano il potere per agire.
Ora, mi stupisce che non si voglia percepire un fatto evidente: le modificazioni climatiche non sono un ipotizzato evento futuro, ma sono già in atto da tempo e sono avvertite quotidianamente dai comuni mortali. La crescente frequenza di fenomeni meteorologici estremi, la comparsa di perturbazioni tipiche degli ambienti tropicali (uragani, tifoni) in zone temperate, l'anomalo andamento della piovosità già basterebbero a fare capire che ci troviamo di fronte a qualche cosa di nuovo. Anche le temperature registrate in questi ultimi anni mostrano che il cambiamento climatico è in corso. Per negare il fenomeno, non basta evidenziare un mese dell'anno più freddo del solito in una particolare località degli USA, oppure una nevicata in Sicilia.
Negli anni Quaranta, quando dal borgo San. Donato, dove abitavo, andavo alla mia scuola elementare (la Sclopis) in via del Carmine, la strada percorsa, da fine novembre ai primi di marzo, era contornata da mucchi di neve che stentava a fondere anche nelle giornate di sole. Alla Pellerina, c'erano due laghetti che in pieno inverno erano gelati e qualche ragazzino si avventurava a pattinare sulla spessa lastra di ghiaccio che li ricopriva. Negli anni Cinquanta, il primo lavoro che, d'inverno, trovavano gli immigrati dal meridione era spalare la neve che più volte copriva tutte le strade di Torino. Visconti descrive il fatto a Milano nel film “Rocco e i suoi fratelli”. Ad inizio anni Sessanta, si sciava in piena estate sul Sommeiller in alta Val di Susa. Oggi, non c'è più traccia del ghiacciaio e fanno tristezza i resti arrugginiti degli impianti di risalita, chiusi nel 1984 e rimasti lì a testimoniare quel passato.
E parliamo di ghiacciai. Tempo fa, un noto economista, di cui è possibile leggere articoli in un importante quotidiano nazionale, negando le modificazioni climatiche, aveva portato a sostegno di tale sua convinzione presunti errori fatti dai climatologi nell'elaborazione dei rilievi delle temperature, errori messi in evidenza da alcuni esperti di statistica. Gli scrissi che, malgrado ciò, i ghiacciai alpini, forse perché ignari di tali considerazioni statistiche, continuavano a fondere e a ritirarsi come poteva constatare chiunque amasse fare escursioni in alta montagna.
Una recente relazione del CNR rileva che, entro ottant’anni, potranno sparire tutti i ghiacciai delle Alpi con conseguenze drammatiche per la stabilità delle montagne (il permafrost fa da collante delle rocce) e per il rifornimento idrico della pianura padana e non solo. I ghiacciai alpini alimentano i principali fiumi europei (Po, Rodano, Reno, Danubio) e in particolare d'estate ne sostengono la portata. E non c'è bisogno di attendere, tra ottant’anni, la scomparsa dei ghiacciai per vedere le conseguenze negative del fenomeno. Già oggi il livello estivo del. Po (e dei suoi affluenti) è estremamente critico e ne risente il sistema di irrigazione dei campi coltivati.
Anche i ghiacciai degli altri continenti sono in fase di contrazione. Prendiamo in considerazione quelli dell'Himalaia, del Karacorum e del Tibet che alimentano i grandi fiumi (Indo, Gange, Bramaputra, Mekong, Fiume Giallo e Fiume Azzurro) da cui dipende l'agricoltura di una regione in cui vive più della metà del genere umano. Forse per scomparire, questi ghiacciai impiegheranno dieci o venti anni in più di quelli alpini, essendo a quota più elevata, ma anche in questo caso non sarà necessario attenderne la scomparsa per verificare le pesanti conseguenze negative sulla popolazione di quella parte del mondo.
Mi sono soffermato sulla fusione dei ghiacciai perché è un fatto molto evidente già oggi, che procede incessantemente e riguarda la quasi totalità dei ghiacciai montani. Ci sono poi tutti gli altri effetti delle modificazioni climatiche che possono essere o diventare ancora più negativi.
Ora, come spiegare il non riconoscimento di queste evidenze da parte di una rilevante componente dell'opinione pubblica e l'atteggiamento di inerzia e di inazione del mondo politico ed economico a fronte di una tale minaccia?
Le varie conferenze sul clima hanno indicato degli obiettivi (fino ad oggi ben al di sotto di quanto è necessario fare), ma quando si passa alla definizione degli strumenti necessari, le misure sono risultate inadeguate in rapporto agli obiettivi dichiarati. In seguito, quelle stesse misure non sono state e non sono osservate se non molto parzialmente. A suo tempo, Tony Blair disse di sapere bene che cosa fosse necessario fare in materia, ma aggiunse che, se avesse cercato di farlo, non lo avrebbero lasciato restare un solo giorno in più al governo. Da queste parole, risulta evidente la motivazione dell'inerzia della classe politica: per timore di perdere consensi, non è in grado di imporre i sacrifici che richiede un serio impegno contro le modificazioni climatiche.
Allora per giustificare un tale comportamento, si minimizza il pericolo da esse rappresentato. Anche la gente comune preferisce vivere alla giornata senza mettere in forse ciò che ha oggi per un domani che preferisce immaginare lontano. Inoltre, coloro che non hanno figli e nipoti (e sono sempre più numerosi) di tale domani, in genere, se ne infischiano altamente.
Ma come si giustifica lo scetticismo di quanti (pur non avendo ruoli politici) hanno istruzione, utilizzano metodi scientifici nel loro lavoro, parlano continuamente di previsioni e della necessità di guardare lontano nella definizione delle scelte? In sostanza, come possono i molti scettici appartenenti alla classe dirigente e al mondo economico chiudere gli occhi di fronte a fatti incontrovertibili?
L'ideologia oggi dominante poggia sul concetto di un progresso materiale fondato sull'onnipotenza della tecnica, capace di garantire una continua disponibilità di risorse e in grado di risolvere ogni problema. Se si introduce il concetto di limite (come avvenne con il famoso rapporto del MIT sui limiti dello sviluppo, promosso dal Club di Roma), questo edificio non regge più e crollano tutti i presupposti su cui si fonda l'ideologia dominante. È ovvio che tutti i suoi sacerdoti e quanti su di essa hanno costruito il loro ruolo e il loro potere non possano accettarlo. Pertanto, a supporto di questa posizione, fino a qualche anno fa, si sosteneva che le previsioni del rapporto del Club di Roma sui limiti della crescita erano fallaci in quanto non si erano avverate, ma oggi le modificazioni climatiche di natura antropica (previste nel predetto rapporto) si presentano come il primo e più rilevante fattore limitante. Negarne l'esistenza o la portata diventa sempre più difficile, e in materia, vediamo fare vere e proprie acrobazie...
Sebbene le modificazioni climatiche non sembrino essere fra le primarie preoccupazioni degli europei, come rilevato da sondaggi eseguiti in vista delle elezioni di maggio, oggi sono accaduti alcuni fatti forse in grado di sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica. Abbiamo ascoltato le preoccupate parole del Presidente della Repubblica sul tema; c'è lo spazio crescente avuto nei media dalla protesta di Greta Thunberg; c'è stata la mobilitazione degli studenti e più in generale dei giovani che hanno raccolto l'appello della giovane svedese ad agire per contrastare le modificazioni climatiche. Sono passi in avanti di cui però non dobbiamo accontentarci perché il tempo limitato per agire ci incalza e non c'è ancora chiarezza sul cammino da intraprendere.
In primo luogo, l'indice viene puntato contro i politici, accusati di essere venuti meno ai loro compiti avendo fatto poco in materia. Ma, come ci dicono le citate parole di Tony Blair, i politici non si muovono perché temono la reazione degli elettori, che finora non hanno mai voluto saperne di pagare il prezzo delle politiche necessarie allo scopo. Alcuni esempi recenti: in Francia, i “gilet gialli” sono scesi in campo per protestare contro una tassa ecologica sui carburanti; in Italia, è subito montata la protesta (con i sindacati in prima fila) per la tassa sull'acquisto di automobili a maggiore emissione di CO2. C'è poi il mondo economico e produttivo per il quale la lotta contro le modificazioni climatiche non deve, in ogni caso, comportare ostacoli o rallentamenti alla crescita del Paese.
In secondo luogo, nella più parte dei discorsi fatti da quanti oggi si preoccupano dei mutamenti climatici, le soluzioni vengono individuate in strumenti tecnologici o, nel caso migliore, in un più responsabile atteggiamento dei consumatori nell'uso e nella gestione dei prodotti (scegliere oggetti di plastica biodegradabile, elettrodomestici a basso consumo, auto elettriche, e via dicendo). È quest'ultimo un fatto positivo, ma largamente insufficiente perché non va al cuore del problema. Infatti, non è stata ancora compresa la necessità che, per combattere le modificazioni climatiche, la popolazione tutta deve fare sacrifici e rinunce, deve sostanzialmente modificare il suo stile di vita, diventare più responsabile in ogni ambito, accantonando l'individualismo dominante.
Già alcuni anni fa, quando la situazione pareva meno drammatica rispetto ad oggi, Barbara Spinelli scriveva su La Stampa: “La questione delle modificazioni climatiche è diventata il riferimento prioritario di ogni politica responsabile. Affrontare questo problema comporta la necessità di cambiare la nostra maniera di vivere e di pensare; ci impone di ripensare i saperi, compreso quello economico e di mutare i modi della politica. Bisogna essere consapevoli che per condurre la battaglia in difesa dell’ambiente, perirà una parte essenziale dell’esperienza liberale: quella parte che, a cominciare dalla rivoluzione industriale, ci ha abituati a credere nel progresso illimitato, nel cittadino-consumatore libero di fare quello che gli piace, nell’aspirazione a una felicità individuale indipendente dall’effetto che essa ha sulla Terra e sull’umanità”.
Ora, mi stupisce che non si voglia percepire un fatto evidente: le modificazioni climatiche non sono un ipotizzato evento futuro, ma sono già in atto da tempo e sono avvertite quotidianamente dai comuni mortali. La crescente frequenza di fenomeni meteorologici estremi, la comparsa di perturbazioni tipiche degli ambienti tropicali (uragani, tifoni) in zone temperate, l'anomalo andamento della piovosità già basterebbero a fare capire che ci troviamo di fronte a qualche cosa di nuovo. Anche le temperature registrate in questi ultimi anni mostrano che il cambiamento climatico è in corso. Per negare il fenomeno, non basta evidenziare un mese dell'anno più freddo del solito in una particolare località degli USA, oppure una nevicata in Sicilia.
Negli anni Quaranta, quando dal borgo San. Donato, dove abitavo, andavo alla mia scuola elementare (la Sclopis) in via del Carmine, la strada percorsa, da fine novembre ai primi di marzo, era contornata da mucchi di neve che stentava a fondere anche nelle giornate di sole. Alla Pellerina, c'erano due laghetti che in pieno inverno erano gelati e qualche ragazzino si avventurava a pattinare sulla spessa lastra di ghiaccio che li ricopriva. Negli anni Cinquanta, il primo lavoro che, d'inverno, trovavano gli immigrati dal meridione era spalare la neve che più volte copriva tutte le strade di Torino. Visconti descrive il fatto a Milano nel film “Rocco e i suoi fratelli”. Ad inizio anni Sessanta, si sciava in piena estate sul Sommeiller in alta Val di Susa. Oggi, non c'è più traccia del ghiacciaio e fanno tristezza i resti arrugginiti degli impianti di risalita, chiusi nel 1984 e rimasti lì a testimoniare quel passato.
E parliamo di ghiacciai. Tempo fa, un noto economista, di cui è possibile leggere articoli in un importante quotidiano nazionale, negando le modificazioni climatiche, aveva portato a sostegno di tale sua convinzione presunti errori fatti dai climatologi nell'elaborazione dei rilievi delle temperature, errori messi in evidenza da alcuni esperti di statistica. Gli scrissi che, malgrado ciò, i ghiacciai alpini, forse perché ignari di tali considerazioni statistiche, continuavano a fondere e a ritirarsi come poteva constatare chiunque amasse fare escursioni in alta montagna.
Una recente relazione del CNR rileva che, entro ottant’anni, potranno sparire tutti i ghiacciai delle Alpi con conseguenze drammatiche per la stabilità delle montagne (il permafrost fa da collante delle rocce) e per il rifornimento idrico della pianura padana e non solo. I ghiacciai alpini alimentano i principali fiumi europei (Po, Rodano, Reno, Danubio) e in particolare d'estate ne sostengono la portata. E non c'è bisogno di attendere, tra ottant’anni, la scomparsa dei ghiacciai per vedere le conseguenze negative del fenomeno. Già oggi il livello estivo del. Po (e dei suoi affluenti) è estremamente critico e ne risente il sistema di irrigazione dei campi coltivati.
Anche i ghiacciai degli altri continenti sono in fase di contrazione. Prendiamo in considerazione quelli dell'Himalaia, del Karacorum e del Tibet che alimentano i grandi fiumi (Indo, Gange, Bramaputra, Mekong, Fiume Giallo e Fiume Azzurro) da cui dipende l'agricoltura di una regione in cui vive più della metà del genere umano. Forse per scomparire, questi ghiacciai impiegheranno dieci o venti anni in più di quelli alpini, essendo a quota più elevata, ma anche in questo caso non sarà necessario attenderne la scomparsa per verificare le pesanti conseguenze negative sulla popolazione di quella parte del mondo.
Mi sono soffermato sulla fusione dei ghiacciai perché è un fatto molto evidente già oggi, che procede incessantemente e riguarda la quasi totalità dei ghiacciai montani. Ci sono poi tutti gli altri effetti delle modificazioni climatiche che possono essere o diventare ancora più negativi.
Ora, come spiegare il non riconoscimento di queste evidenze da parte di una rilevante componente dell'opinione pubblica e l'atteggiamento di inerzia e di inazione del mondo politico ed economico a fronte di una tale minaccia?
Le varie conferenze sul clima hanno indicato degli obiettivi (fino ad oggi ben al di sotto di quanto è necessario fare), ma quando si passa alla definizione degli strumenti necessari, le misure sono risultate inadeguate in rapporto agli obiettivi dichiarati. In seguito, quelle stesse misure non sono state e non sono osservate se non molto parzialmente. A suo tempo, Tony Blair disse di sapere bene che cosa fosse necessario fare in materia, ma aggiunse che, se avesse cercato di farlo, non lo avrebbero lasciato restare un solo giorno in più al governo. Da queste parole, risulta evidente la motivazione dell'inerzia della classe politica: per timore di perdere consensi, non è in grado di imporre i sacrifici che richiede un serio impegno contro le modificazioni climatiche.
Allora per giustificare un tale comportamento, si minimizza il pericolo da esse rappresentato. Anche la gente comune preferisce vivere alla giornata senza mettere in forse ciò che ha oggi per un domani che preferisce immaginare lontano. Inoltre, coloro che non hanno figli e nipoti (e sono sempre più numerosi) di tale domani, in genere, se ne infischiano altamente.
Ma come si giustifica lo scetticismo di quanti (pur non avendo ruoli politici) hanno istruzione, utilizzano metodi scientifici nel loro lavoro, parlano continuamente di previsioni e della necessità di guardare lontano nella definizione delle scelte? In sostanza, come possono i molti scettici appartenenti alla classe dirigente e al mondo economico chiudere gli occhi di fronte a fatti incontrovertibili?
L'ideologia oggi dominante poggia sul concetto di un progresso materiale fondato sull'onnipotenza della tecnica, capace di garantire una continua disponibilità di risorse e in grado di risolvere ogni problema. Se si introduce il concetto di limite (come avvenne con il famoso rapporto del MIT sui limiti dello sviluppo, promosso dal Club di Roma), questo edificio non regge più e crollano tutti i presupposti su cui si fonda l'ideologia dominante. È ovvio che tutti i suoi sacerdoti e quanti su di essa hanno costruito il loro ruolo e il loro potere non possano accettarlo. Pertanto, a supporto di questa posizione, fino a qualche anno fa, si sosteneva che le previsioni del rapporto del Club di Roma sui limiti della crescita erano fallaci in quanto non si erano avverate, ma oggi le modificazioni climatiche di natura antropica (previste nel predetto rapporto) si presentano come il primo e più rilevante fattore limitante. Negarne l'esistenza o la portata diventa sempre più difficile, e in materia, vediamo fare vere e proprie acrobazie...
Sebbene le modificazioni climatiche non sembrino essere fra le primarie preoccupazioni degli europei, come rilevato da sondaggi eseguiti in vista delle elezioni di maggio, oggi sono accaduti alcuni fatti forse in grado di sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica. Abbiamo ascoltato le preoccupate parole del Presidente della Repubblica sul tema; c'è lo spazio crescente avuto nei media dalla protesta di Greta Thunberg; c'è stata la mobilitazione degli studenti e più in generale dei giovani che hanno raccolto l'appello della giovane svedese ad agire per contrastare le modificazioni climatiche. Sono passi in avanti di cui però non dobbiamo accontentarci perché il tempo limitato per agire ci incalza e non c'è ancora chiarezza sul cammino da intraprendere.
In primo luogo, l'indice viene puntato contro i politici, accusati di essere venuti meno ai loro compiti avendo fatto poco in materia. Ma, come ci dicono le citate parole di Tony Blair, i politici non si muovono perché temono la reazione degli elettori, che finora non hanno mai voluto saperne di pagare il prezzo delle politiche necessarie allo scopo. Alcuni esempi recenti: in Francia, i “gilet gialli” sono scesi in campo per protestare contro una tassa ecologica sui carburanti; in Italia, è subito montata la protesta (con i sindacati in prima fila) per la tassa sull'acquisto di automobili a maggiore emissione di CO2. C'è poi il mondo economico e produttivo per il quale la lotta contro le modificazioni climatiche non deve, in ogni caso, comportare ostacoli o rallentamenti alla crescita del Paese.
In secondo luogo, nella più parte dei discorsi fatti da quanti oggi si preoccupano dei mutamenti climatici, le soluzioni vengono individuate in strumenti tecnologici o, nel caso migliore, in un più responsabile atteggiamento dei consumatori nell'uso e nella gestione dei prodotti (scegliere oggetti di plastica biodegradabile, elettrodomestici a basso consumo, auto elettriche, e via dicendo). È quest'ultimo un fatto positivo, ma largamente insufficiente perché non va al cuore del problema. Infatti, non è stata ancora compresa la necessità che, per combattere le modificazioni climatiche, la popolazione tutta deve fare sacrifici e rinunce, deve sostanzialmente modificare il suo stile di vita, diventare più responsabile in ogni ambito, accantonando l'individualismo dominante.
Già alcuni anni fa, quando la situazione pareva meno drammatica rispetto ad oggi, Barbara Spinelli scriveva su La Stampa: “La questione delle modificazioni climatiche è diventata il riferimento prioritario di ogni politica responsabile. Affrontare questo problema comporta la necessità di cambiare la nostra maniera di vivere e di pensare; ci impone di ripensare i saperi, compreso quello economico e di mutare i modi della politica. Bisogna essere consapevoli che per condurre la battaglia in difesa dell’ambiente, perirà una parte essenziale dell’esperienza liberale: quella parte che, a cominciare dalla rivoluzione industriale, ci ha abituati a credere nel progresso illimitato, nel cittadino-consumatore libero di fare quello che gli piace, nell’aspirazione a una felicità individuale indipendente dall’effetto che essa ha sulla Terra e sull’umanità”.
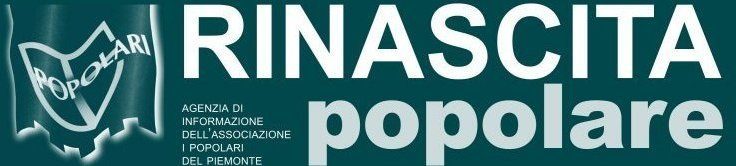
Caro Ladetto, non sto a dirti né quanto ti stimi né quanto apprezzi l’articolo, vorrei fare un’aggiunta o meglio lanciare un forte messaggio che sinora non sono stato in grado di far udire a nessuno. Speriamo che da queste colonne qualcuno lo raccolga. L’acqua, diminuirà in continuazione ma quanta ne sprechiamo volutamente? Leggete qui per favore!
Arriviamo dopo una estate rovente, un autunno così così, un inverno asciuttissimo, e l’acqua è sempre più scarsa.…. Si sa, dovremmo imparare a sprecarne meno, ci mancherebbe! Però pochi sanno e sono al corrente che un vero mostro, un Moloch terribile sta prosciugando quello che abbiamo di più prezioso: le falde acquifere. Non ne sto parlando non perché ho visto l’ennesimo sermone di qualche guru ambientalista, ma perché è la realtà nuda e cruda certificata dall’ordine degli ingegneri, come puoi vedere qui appresso.
Sto parlando delle famose pompe di calore, quelle che sfruttano il differenziale di temperatura dell’acqua estratta dalle falde e che trova nell’impianto di climatizzazione del grattacielo Intesa San Paolo una delle sue applicazioni .
Tratto dal sito :
http://www.ingegneri.info/news/impianti/grattacielo-intesa-sanpaolo-di-torino-la-climatizzazione/
……nessuna emissione di CO2 in atmosfera, massima efficienza energetica in tutte le stagioni e sfruttamento di risorse rinnovabili come l’acqua di falda, con la conseguente riduzione dei costi di gestione, sono i fattori di successo in progetti come questo.”
Come è possibile dire che l’acqua di falda, la più preziosa che c’è e che impiega secoli a formarsi, è una energia rinnovabile?
Quanti milioni di litri d’acqua vengono sprecati giornalmente? L’acqua di falda non è l’acqua di una roggia o di un fiume, non si rinnova per niente! Di questo passo tra qualche anno saranno anche i rubinetti dell’acqua domestica ad essere a secco… e nessuno ne parla! L’unico documento preoccupato sull’argomento è un estratto di un documento redatto dalla Città metropolitana di Milano, che nelle analisi dice chiaramente che senza controllo sull’uso dell’acqua per ragioni energetiche ed irrigue in futuro l’approvvigionamento idrico per uso domestico e industriale è messo a rischio, ripeto l’unico documento trovato che dia un “warning” in merito. Se la redazione può prendere questo commento ed evidenziarlo graficamente farà cosa buona e giusta.
Circa il bellissimo articolo dell’amico Beppe Ladetto penso possa essere riassunto in una sola parola, esplicativa di quanto sta avvenendo e perchè: tale parola è EGOISMO in tutte le sue forme. Non stupisca che siano solo coloro che sono spinti da qualche ideale a pensare al futuro in termini strategici. L’osservazione di Mila ci ricorda inoltre quanto sia pericoloso banalizzare i problemi energetici e perdere di vista la loro interconnessione.
Non ho certo bisogno di confermare il mio apprezzamento per Beppe Ladetto ed i suoi scritti e preciso che non sono affatto un “negazionista” rispetto ai fenomeni che lui ha trattato. Ho però un dubbio che mi piacerebbe fosse sciolto da chi maneggia la materia.
E’ indiscutibile che anche in passato si siano rilevati fenomeni in qualche modo simili: pensando ai ghiacciai io condivido anche i ricordi personali sul Sommelier, ecc… ma ricordo che in un epoca non troppo lontana (si fa per dire) i ghiacciai si ritirarono e i valichi alpini si resero facilmente transitabili, generando per esempio il trasferimento e lo stanziamento di popolazioni di lingua tedesca, i Walser, sui nostri versanti, in valle d’Aosta e Ossola. Una successiva glaciazione ricreò poi una ricrescita dei ghiacciai stessi.
Sono andato a memoria e forse sono stato impreciso ma mi domando se tra questi fenomeni ci può essere una parentela, dando per scontato che, allora, le cause antropiche non abbiano giocato alcun ruolo.
Mi consenta l’amico Campia di far presente che l’origine antropica del mutamento climatico è stato riconosciuto come in buona parte dovuto al livello di anidride carbonica presente nell’atmosfera che dagli scienziati è stato definito mai così alto da quando l’uomo è comparso sulla terra.
Ma qui vorrei soffermarmi sul perché ormai l’uomo tecnologico non può più fermare la macchina produttiva che ha messo in piedi (salvo qualche piccolo accorgimento che decelera il processo per scusarsi con se stesso). A mio modo di vedere il progresso tecnologico ha mutato la natura degli apparati produtivi che, da fornitori di beni più o meno indispensabili per la vita si sono trasformati in una sorta di macchina da guerra per affermare un primato politico nella lotta tra stati sul mercato mondiale. Ieri la ricchezza degli stati imperiali era data dall’impossessamento dei territori di altri stati più deboli mediante vittorie militari ottenute sui campi di battaglia. La cultura antica ne era ben conscia, non a caso S. Agostino cita la vecchia storiella, riportata da Cicerone, di Alessandro Magno ed il pirata in cui fa ben presente che è solo se un re esercita il potere distribuendo la ricchezza con giustizia che questi si differernzia da un pirata, dal momento che la realtà nuda e cruda del mero comportamento materiale della politica non differisce in nulla da quella di un pirata, o bandito che dir si voglia. Il moderno von Klausewitz ne era ben conscio quando scriveva che “la guerra è la prosecuzione della politica con altri mezzi”. Nel secolo scorso l’uso di terribili e potentissimi mezzi bellici ha sconsigliato (nei limiti del possibile) di regolare le questioni geopolitiche mediante lo strumento bellico e ha scoperto che si può sconfiggere una nazione (più propriamente un impero di dimensioni continentali può distruggerne un altro di pari dimensione e popolazione) utilizzando il metodo dell’economia capitalistica globalizzata. Schumpeter definiva il capitalismo come una forma di “distruzione creatrice” ma ciò, col rescere a dismisura della base industriale del mondo, ha finito col trasformarsi in una forma di “creazione distruttiva” sostituendo la guerra come mezzo di prosecuzione della politica di potenza.
Questo cambio di finalità per sua natura è destinato a far perdere di vista ogni ragionevole rapporto tra natura e deliri di potenza umani e a proporsi falsamente come una forma crescita del benessere dell’umanità che in realtà viene irretita in un vortice autodistruttivo che, chi continua a ragionare in termini di progresso dell’umanità, in base alla concezione filosofica della storia che ha dominato nei due secoli e mezzo precedenti al presente, non è in grado di vedere la realtà attuale in quanto si serve di categorie mentali inadeguate a descrivere e spiegare la realtà (ma perché sta succedento che la “pancia populista” sta prendendendo il posto della “razionalità responsabile” delle élites: evidentemente perché questa “razionalità” di razionale non ci ha proprio nulla, dal momento che si serve di categorie mentali completamente aliene alla realtà presente). La grande spia della “creazione distruttiva” del sistema resta per lo più nascosta alle grandi masse dalla diffusione da parte dell’establishement, che cerca di continuare a far passare se stesso da dispensatore di ricchezza, una funzione sempre più smentita dai fatti proprio perché come tutte le guerre, anche quella giocata sui mercati e nelle borse crea un mucchio di danni e sostanzialmente distrugge ricchezza. Appunto quei danni all’ambiente che stanno pian pianino spostando l’aumento della miseria e dell’esposizione alle malattie verso le nuove generazioni. Possiamo dire che, dopo la fase della lotta per una equa distribuzione della ricchezza tra le classi sociali di uno stesso stato (lotta di classe), dopo la lotta, per dirla con Mao, tra “città e campagna”, cioè tra stati industrializzati e stati basati sull’economia agricola, per la distribuzione delle risorse mondiali si è aperta la terza fase, quella della lotta tra le generazioni. L’umanità non ha capito che ogni eccesso produttivo di una generazione viene in vario modo e per vari motivi, sottratta alle generazioni successive. Il particolare in quanto la terra è limitata (l’idea filosofica di progressso si basava su di una concezione infinita delle risorse e non si capiva che la tecnologia può dare soluzione solo a specifici problemi, più o meno complessi, ma che gli equilibribri naturali, oltre certi limiti, sono fuori dalla portata umana) e ha i suoi ritmi di rigenerazione non sono quelli della macchina industriale. Nè la crescita della popolazione (anch’essa frutto della tecnologia) può impunemente superare certi numeri.
Sono questi incoffessabili motivi che rendono difficile, per non dire impossibile la battaglia per un un armonioso rapporto tra economia moderna ed equilibri ecologici (che richiederebbe, probabilmente attraverso conflitti terribili, radicali redistribuzioni dell’intero potere mondiale). I mezzi a disposizione dell’istinto di potenza dell’uomo moderno hanno fatto passi da gigante ma gli uomini non hanno capito (aggiungiamoci un ottimistico “ancora”) che la presenza stessa di tali mezzi deve portare ad una sapiente e armonica autolimitazione.
Purtropo la storia ci insegna come avvengono i grandi mutamenti culturali, che solamente tali non sono mai.
L’amico Franco Campia fa riferimento ad uno degli argomenti portati da quanti prospettano che le modificazioni climatiche in corso non siano di natura antropica, ma siano della stessa natura di alcuni cambiamenti avvenuti nell’ultimo millennio: un caldo alto medioevo e una successiva piccola glaciazione terminata a metà del XIX secolo. A prova del caldo periodo medievale, adducono la scomparsa o la marcata riduzione dei ghiacciai alpini e del ghiaccio che ricopriva la Groenlandia (detta appunto “Terra verde” perché ricoperta di prati e boschi) e delle isole circonvicine. Non considero, per brevità, il fatto che costoro lasciano da parte la correlazione stretta esistente tra % di gas-serra in atmosfera e temperatura terrestre, e vengo a quanto detto sopra. Sul tema dei ghiacciai alpini, mi rifaccio a quanto osservato da Luca Mercalli. Il ritrovamento del corpo mummificato di Otzi, rilasciato dalla fusione del ghiacciaio del Similaun, dove si trovava da oltre 5000 anni, ci dice che da allora quel ghiacciaio non si è mai fuso o marcatamente ritirato. Riscontri analoghi relativi a manufatti di natura organica rilasciati di recente da ghiacciai svizzeri testimoniano lo stesso fatto: non c’è mai stata nel medioevo una scomparsa o una rilevante riduzione dei ghiacciai alpini. Quanto alla Groenlandia libera dai ghiacci, si pensi che ciò avrebbe comportato un aumento del livello del mare incompatibile con la nascita e la sopravvivenza di Venezia e messo in gravi difficoltà (all’epoca della nascita delle repubbliche marinare) molte altre città di mare.
I cambiamenti climatici avvenuti nel corso del secondo millennio, il caldo medioevo (desunto da cronache) e la successiva cosiddetta piccola glaciazione, sembrano essere relativi ai soli paesi affacciati sul nord Atlantico, non essendone documentata l’estensione geografica ad altre parti del mondo. Se ne possono supporre, quali fattori causali di carattere locale, fenomeni vulcanici e/o modificazioni delle correnti marine.
Fra gli importanti fattori generali di cambiamento climatico, ci sono i parametri di Milankovitch, alla base delle glaciazioni (la combinazione fra le variazioni di inclinazione dell’asse terrestre, le variazioni dell’eccentricità dell’orbita e la precessione degli equinozi) con un ciclo di circa 100.000 anni, mentre una significativa variazione (in crescita) dell’irraggiamento solare si è realizzata nel corso di milioni di anni; variazioni di ciclo breve (una decina di anni) causano ricadute sulla Terra di scarsissima rilevanza climatica. Nessuna causa naturale è in grado in tempi brevi di produrre i rilevanti cambiamenti in corso.
Forse ho perso la capacità di scrivere e di illustrare i problemi, ma sinceramente di fronte ad una denuncia così grave come quella dello sciupio dell’acqua di falda per climatizzare abitazioni ed un grattacielo, in un momento storico in cui tutti dicono che la prossima guerra sarà quella dell’acqua, non aver ricevuto nemmeno un commento né a favore o a sfavore mi lascia perplesso. Che nessuno si preoccupi della penuria di acqua mi fa solo aggiungere un valido motivo di preoccupazione ai tanti che vengono riportati nello spettacolo tragicomico ” Destinati all’estinzione” di Angelo Pintus.