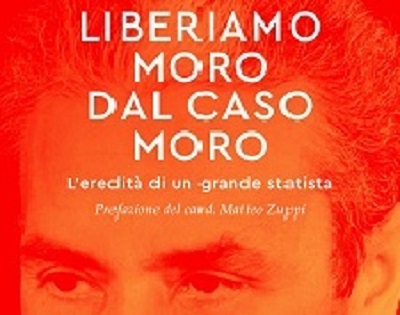
Difficile, se non impossibile, quando si parla di Aldo Moro, non pensare alla sua tragica fine. Via Fani - la strada in cui fu rapito e trovarono la morte i cinque agenti della sua scorta - finisce inevitabilmente sempre in primo piano. Il giornalista di Avvenire, Angelo Picariello nel libro "Liberiamo Moro dal caso Moro” (edizioni San Paolo), prova invece a parlarci dello statista Dc mettendo da parte quanto avvenne nella primavera del 1978, per concentrarsi piuttosto sui valori che lo ispiravano e che trasfondeva nell' azione politica.
Sin dalla Costituente, dove fu eletto appena trentenne, Moro emerge come un uomo politico di eccezionale levatura etica e culturale. Non a caso il suo pensiero ha fortemente influenzato l'esito dei lavori di stesura della Costituzione. Nella Commissione dei 75, incaricata di redigere il testo, trovò spazio la sua impronta personalista che venne trasfusa nei più importanti articoli della Carta. Fu infatti lui ad individuare alcuni dei termini più significativi che vi risaltano.
Pensiamo a quel “riconoscere" nell'art. 2, riferito ai diritti inviolabili dell'uomo che preesistono allo Stato e, per l'appunto, da riconoscersi anche nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità. Così come nell'art. 3, il verbo “rimuovere” parlando degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona. Impegno che la Repubblica assume per la loro eliminazione. Fu in quella sede costituente, dove si confrontarono visioni diverse, spesso antitetiche, che il giovane deputato pugliese ebbe modo di farsi apprezzare, da colleghi più anziani e più navigati come il leader del Pci, Palmiro Togliatti o il latinista Concetto Marchesi, per l'acutezza delle sue riflessioni giuridiche e la capacità di ricomporre tesi e posizioni diverse. Qualità che poi ritroveremo negli anni a venire, nel corso di tutta la sua vita pubblica.
Picariello ripercorre le tappe della carriera politica di Moro che, dopo la Costituente, approdò al Governo. Dapprima come ministro della Giustizia, operando per un sistema carcerario in linea con il dettato costituzionale, volto alla rieducazione del condannato, e poi alla Pubblica Istruzione, fautore di una scuola inclusiva, da cui prese le mosse la media unica. Attività ministeriale cui seguì l'ascesa alla segreteria della Dc.
Siamo nel 1959. Moro ha 43 anni e da quel momento - sia guidando diversi governi sia rimanendone fuori - si pone come l'artefice delle principali strategie politiche del Paese: dall'ingresso dei socialisti al governo con l'apertura a sinistra, sino all'ultima tappa della sua vita con il coinvolgimento del Pci nella solidarietà nazionale. “Strategia dell'attenzione”, “convergenze parallele”, “equilibri sociali più avanzati”: formulazioni del lessico moroteo che divennero familiari al grande pubblico. In esse, seppur non sempre pienamente comprese, si denotava l'incessante volontà di allargare le basi politiche della nostra democrazia includendovi quante più forze possibili.
Moro fu anche un grande protagonista nella ricerca di nuovi e più pacifici assetti internazionali. In questo spirito spicca la Conferenza di Helsinki del 1975 di cui fu uno dei tessitori. Appuntamento ancor oggi considerato come una delle stagioni più promettenti in vista di relazioni tra gli Stati basate sulla forza del diritto anziché sul diritto della forza.
Ultima fase fu quella dell'incontro tra i due grandi partiti popolari, Dc e Pci, per scongiurare possibili svolte autoritarie. In tutto questo vediamo stagliarsi la figura di un leader capace, più di qualsiasi altro, di cogliere quanto si muoveva sotto traccia nella società italiana e in particolare nel mondo giovanile. Quelle inquietudini e quelle aspirazioni, che furono purtroppo accompagnate dalla violenza, trovarono in Moro un attento osservatore. Una nuova generazione, con il ribollire del '68, stava affacciandosi alla scena pubblica. Con l'amaro paradosso che le Br - nelle cui farneticazioni non pochi giovani videro un possibile sbocco per le loro utopie - uccisero l'uomo politico più propenso al dialogo, all'incontro, alla comprensione.
Sin dalla Costituente, dove fu eletto appena trentenne, Moro emerge come un uomo politico di eccezionale levatura etica e culturale. Non a caso il suo pensiero ha fortemente influenzato l'esito dei lavori di stesura della Costituzione. Nella Commissione dei 75, incaricata di redigere il testo, trovò spazio la sua impronta personalista che venne trasfusa nei più importanti articoli della Carta. Fu infatti lui ad individuare alcuni dei termini più significativi che vi risaltano.
Pensiamo a quel “riconoscere" nell'art. 2, riferito ai diritti inviolabili dell'uomo che preesistono allo Stato e, per l'appunto, da riconoscersi anche nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità. Così come nell'art. 3, il verbo “rimuovere” parlando degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona. Impegno che la Repubblica assume per la loro eliminazione. Fu in quella sede costituente, dove si confrontarono visioni diverse, spesso antitetiche, che il giovane deputato pugliese ebbe modo di farsi apprezzare, da colleghi più anziani e più navigati come il leader del Pci, Palmiro Togliatti o il latinista Concetto Marchesi, per l'acutezza delle sue riflessioni giuridiche e la capacità di ricomporre tesi e posizioni diverse. Qualità che poi ritroveremo negli anni a venire, nel corso di tutta la sua vita pubblica.
Picariello ripercorre le tappe della carriera politica di Moro che, dopo la Costituente, approdò al Governo. Dapprima come ministro della Giustizia, operando per un sistema carcerario in linea con il dettato costituzionale, volto alla rieducazione del condannato, e poi alla Pubblica Istruzione, fautore di una scuola inclusiva, da cui prese le mosse la media unica. Attività ministeriale cui seguì l'ascesa alla segreteria della Dc.
Siamo nel 1959. Moro ha 43 anni e da quel momento - sia guidando diversi governi sia rimanendone fuori - si pone come l'artefice delle principali strategie politiche del Paese: dall'ingresso dei socialisti al governo con l'apertura a sinistra, sino all'ultima tappa della sua vita con il coinvolgimento del Pci nella solidarietà nazionale. “Strategia dell'attenzione”, “convergenze parallele”, “equilibri sociali più avanzati”: formulazioni del lessico moroteo che divennero familiari al grande pubblico. In esse, seppur non sempre pienamente comprese, si denotava l'incessante volontà di allargare le basi politiche della nostra democrazia includendovi quante più forze possibili.
Moro fu anche un grande protagonista nella ricerca di nuovi e più pacifici assetti internazionali. In questo spirito spicca la Conferenza di Helsinki del 1975 di cui fu uno dei tessitori. Appuntamento ancor oggi considerato come una delle stagioni più promettenti in vista di relazioni tra gli Stati basate sulla forza del diritto anziché sul diritto della forza.
Ultima fase fu quella dell'incontro tra i due grandi partiti popolari, Dc e Pci, per scongiurare possibili svolte autoritarie. In tutto questo vediamo stagliarsi la figura di un leader capace, più di qualsiasi altro, di cogliere quanto si muoveva sotto traccia nella società italiana e in particolare nel mondo giovanile. Quelle inquietudini e quelle aspirazioni, che furono purtroppo accompagnate dalla violenza, trovarono in Moro un attento osservatore. Una nuova generazione, con il ribollire del '68, stava affacciandosi alla scena pubblica. Con l'amaro paradosso che le Br - nelle cui farneticazioni non pochi giovani videro un possibile sbocco per le loro utopie - uccisero l'uomo politico più propenso al dialogo, all'incontro, alla comprensione.
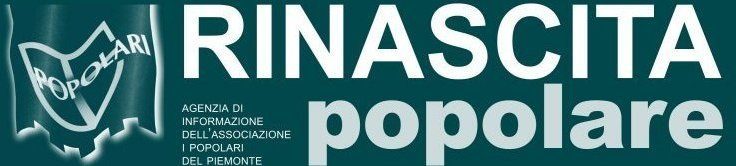
Lascia un commento