
Il 9 maggio 2025 abbiamo festeggiato il 75° anniversario della Giornata dell’Europa. Ogni anno, in questo giorno, celebriamo la pace e l’unità in Europa: la data segna l’anniversario della «dichiarazione Schuman», la storica proposta presentata nel 1950 dal ministro degli Esteri francese Robert Schuman, che ha gettato le basi della cooperazione europea; la proposta Schuman è considerata l’atto di nascita di quella che oggi è l’Unione europea.
«La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano. Il contributo che un’Europa organizzata e vitale può apportare alla civiltà è indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche. […] L’Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto».
Sono le parole che Schuman scrive nello storico documento in cui proponeva la creazione di una Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA), i cui membri avrebbero messo in comune la produzione di questi materiali, con cui si producevano – e si producono – armi. La CECA (i cui Paesi fondatori sono la Francia, la Germania occidentale, l’Italia, i Paesi Bassi, il Belgio ed il Lussemburgo) è stata la prima di una serie di istituzioni europee sovranazionali che avrebbero infine portato alla nascita di quella che oggi è l’Unione europea.
Lo statista italiano, Alcide De Gasperi (Pieve Tesino-TN, 3 aprile 1881- Sella di Valsugana-TN, 19 agosto 1954) – di cui ricordiamo, in questo mese di agosto, il 71° anniversario della sua scomparsa – ha offerto un fondamentale e prezioso contributo alla costruzione di quella che egli definisce la «nostra patria Europa»: De Gasperi, oltre ad essere stato, nel secondo dopoguerra, ricostruttore d’Italia e padre della Repubblica italiana, è considerato padre cofondatore dell’Unione europea (cfr. Leonardo Brancaccio, Alcide De Gasperi. Cittadinanza attiva, buona politica, bene comune, Ecra, Roma 2024).
In seguito alla guerra in Corea (il 25 giugno 1950 le truppe della Corea del Nord invadono la Corea del Sud: in tutto il mondo si diffonde il timore che le operazioni militari nell’estremo oriente fossero la prova generale di un’aggressione comunista all’Europa occidentale), De Gasperi, per garantire la difesa dell’Europa occidentale da un possibile attacco sovietico – si parlava anche di un riarmo della Germania –, appoggia la proposta francese della costituzione di un esercito integrato europeo.
Lo statista trentino era convinto che l’unità dell’Europa si sarebbe potuta realizzare con l’esercito (la cosiddetta Comunità Europea di Difesa - CED) o con la moneta; per De Gasperi, partire da una integrazione limitata ai soli aspetti militari era solo il primo passo per arrivare ad una integrazione politica ed economica (cfr. Alfredo Canavero, Alcide De Gasperi. Cristiano, democratico, europeo, Roma, Fondazione De Gasperi e Gruppo del PPE al Parlamento europeo, Bruxelles 2019, p. 122 e ss.).
Lo statista trentino si impegna per trasformare il progetto originario della CED nel nucleo motore di una futura Comunità politica europea: grazie alle sue insistenze, nell’art. 38 del trattato istitutivo della CED si prevede che all’Assemblea della CED siano affidati poteri costituenti, per elaborare una organica proposta in senso federale.
Il 27 maggio 1952 a Parigi viene sottoscritto il trattato istitutivo della CED da parte dei sei Paesi che avevano costituito la CECA (Italia, Francia, Repubblica Federale Tedesca, Belgio, Olanda, Lussemburgo); il trattato sarebbe entrato in vigore in seguito alla ratifica di tutti i parlamenti degli Stati firmatari.
Il 24 settembre 1952 il presidente del Consiglio De Gasperi si reca nella città tedesca di Aquisgrana per ricevere il prestigioso «Premio Carlo Magno»; nel suo discorso richiama, tra l’altro, i passi che i vari Paesi europei stavano svolgendo per costruire l’unità europea:
«Il segreto del Piano Schuman sta appunto in questo: che la buona volontà degli Stati partecipanti viene subito agganciata a organi impegnativi ed esecutivi di solidarietà e di responsabilità comuni. Quando domani sarà ratificato anche il Trattato della comune difesa, noi avremo creato, dissodato e fecondato dei campi entro i quali il buon seme della pace e dell’unità crescerà rigoglioso fra le nuove generazioni […]. La fede ci sostiene e l’ottimismo, quando si tratta di realizzare un grande ideale politico e umano quale la riunificazione europea, è virtù costruttiva».
Ma De Gasperi, in uno dei passaggi più alti del discorso di Aquisgrana, mette in evidenza la necessità di una condizione fondamentale e necessaria per la riunificazione, ossia la formazione della «mentalità europea»: «Di pari passo però con il rafforzamento e l’accrescimento di potere delle istituzioni federali, devono procedere i progressi di una mentalità europea. Le istituzioni supernazionali sarebbero insufficienti e rischierebbero di diventare una palestra di competizioni di interessi particolari, se gli uomini ad esse preposti non si sentissero mandatari di interessi superiori ed europei. Senza la formazione di questa mentalità europea ogni nostra formula rischia di rimanere una vuota astrazione giuridica».
L’11 maggio 1954 De Gasperi è eletto all’unanimità presidente dell’Assemblea della CECA: è un grande riconoscimento per uno statista e politico europeista come lui che, dopo la fine della Seconda guerra mondiale, ha dedicato tanto lavoro non solo alla ricostruzione dell’Italia ma anche alla costruzione dell’unità in Europa.
A Strasburgo, De Gasperi accetta la nomina a presidente dell’Assemblea comune della CECA e pronuncia un forte discorso europeista sostenendo la causa della ratifica della CED: mancavano solo le ratifiche dell’Italia e della Francia, e quest’ultima si presentava particolarmente difficile .
Nel discorso di Strasburgo, innanzi all’Assemblea comune della CECA, ribadisce l’impegno a continuare l’opera avviata da Robert Schuman e da Jean Monnet, auspicando ulteriori sviluppi sulla via dell’unità europea. Il neopresidente De Gasperi invita tutti i membri, soprattutto nei momenti di difficoltà impreviste, a non dimenticare l’obiettivo e la ragion d’essere del comune lavoro – che è l’«organizzazione della pace» – e a non far mancare il «senso di responsabilità» e di «corresponsabilità più ampio di quella che è la competenza specifica della Comunità».
Il 30 agosto 1954 – undici giorni dopo la sua morte (Sella di Valsugana, 19 agosto) – il Parlamento francese non ratifica il trattato della CED ed il progetto va alla deriva; ma l’opera dello statista trentino rimane, in parte, incompiuta: come rileva Jean-Dominique Duran «il metodo funzionalista ripreso nelle Conferenze europee successive (Messina, Venezia) e con i Trattati di Roma del 1957, e i suoi moniti sulla necessaria unità politica, sul rispetto delle nazioni nella costruzione di tale entità politica, sui contenuti che non possono essere soltanto di tipo tecnico ma devono portare avanti un vero ideale europeistico al quale fare aderire i popoli, restano attualità» (cfr. Jean-Dominique Durand, Alcide De Gasperi e la Patria europea, in Giuseppe Tognon (a cura di), Su De Gasperi. Dieci lezioni di storia e di politica, FBK Press, Trento 2013, p. 72).
Secondo Igino Giordani è “l’unità” la mèta verso cui De Gasperi ha camminato, scalando rocce acuminate e oscillanti (cfr. Igino Giordani, Alcide De Gasperi, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1955, p. 361).
L’anno precedente alla sua morte, De Gasperi, in occasione della seduta pubblica d’apertura della Tavola rotonda d’Europa (Roma, 13 ottobre 1953), pronuncia le seguenti parole: «La tendenza all’unità è – mi sembra – una delle “costanti” della storia […] noi lavoriamo per l’unità, non per la divisione […]».
Il pensiero, le opere e la testimonianza di Alcide De Gasperi sono perciò di grande attualità.
(Tratto da www.cittanuova.it)
«La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano. Il contributo che un’Europa organizzata e vitale può apportare alla civiltà è indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche. […] L’Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto».
Sono le parole che Schuman scrive nello storico documento in cui proponeva la creazione di una Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA), i cui membri avrebbero messo in comune la produzione di questi materiali, con cui si producevano – e si producono – armi. La CECA (i cui Paesi fondatori sono la Francia, la Germania occidentale, l’Italia, i Paesi Bassi, il Belgio ed il Lussemburgo) è stata la prima di una serie di istituzioni europee sovranazionali che avrebbero infine portato alla nascita di quella che oggi è l’Unione europea.
Lo statista italiano, Alcide De Gasperi (Pieve Tesino-TN, 3 aprile 1881- Sella di Valsugana-TN, 19 agosto 1954) – di cui ricordiamo, in questo mese di agosto, il 71° anniversario della sua scomparsa – ha offerto un fondamentale e prezioso contributo alla costruzione di quella che egli definisce la «nostra patria Europa»: De Gasperi, oltre ad essere stato, nel secondo dopoguerra, ricostruttore d’Italia e padre della Repubblica italiana, è considerato padre cofondatore dell’Unione europea (cfr. Leonardo Brancaccio, Alcide De Gasperi. Cittadinanza attiva, buona politica, bene comune, Ecra, Roma 2024).
In seguito alla guerra in Corea (il 25 giugno 1950 le truppe della Corea del Nord invadono la Corea del Sud: in tutto il mondo si diffonde il timore che le operazioni militari nell’estremo oriente fossero la prova generale di un’aggressione comunista all’Europa occidentale), De Gasperi, per garantire la difesa dell’Europa occidentale da un possibile attacco sovietico – si parlava anche di un riarmo della Germania –, appoggia la proposta francese della costituzione di un esercito integrato europeo.
Lo statista trentino era convinto che l’unità dell’Europa si sarebbe potuta realizzare con l’esercito (la cosiddetta Comunità Europea di Difesa - CED) o con la moneta; per De Gasperi, partire da una integrazione limitata ai soli aspetti militari era solo il primo passo per arrivare ad una integrazione politica ed economica (cfr. Alfredo Canavero, Alcide De Gasperi. Cristiano, democratico, europeo, Roma, Fondazione De Gasperi e Gruppo del PPE al Parlamento europeo, Bruxelles 2019, p. 122 e ss.).
Lo statista trentino si impegna per trasformare il progetto originario della CED nel nucleo motore di una futura Comunità politica europea: grazie alle sue insistenze, nell’art. 38 del trattato istitutivo della CED si prevede che all’Assemblea della CED siano affidati poteri costituenti, per elaborare una organica proposta in senso federale.
Il 27 maggio 1952 a Parigi viene sottoscritto il trattato istitutivo della CED da parte dei sei Paesi che avevano costituito la CECA (Italia, Francia, Repubblica Federale Tedesca, Belgio, Olanda, Lussemburgo); il trattato sarebbe entrato in vigore in seguito alla ratifica di tutti i parlamenti degli Stati firmatari.
Il 24 settembre 1952 il presidente del Consiglio De Gasperi si reca nella città tedesca di Aquisgrana per ricevere il prestigioso «Premio Carlo Magno»; nel suo discorso richiama, tra l’altro, i passi che i vari Paesi europei stavano svolgendo per costruire l’unità europea:
«Il segreto del Piano Schuman sta appunto in questo: che la buona volontà degli Stati partecipanti viene subito agganciata a organi impegnativi ed esecutivi di solidarietà e di responsabilità comuni. Quando domani sarà ratificato anche il Trattato della comune difesa, noi avremo creato, dissodato e fecondato dei campi entro i quali il buon seme della pace e dell’unità crescerà rigoglioso fra le nuove generazioni […]. La fede ci sostiene e l’ottimismo, quando si tratta di realizzare un grande ideale politico e umano quale la riunificazione europea, è virtù costruttiva».
Ma De Gasperi, in uno dei passaggi più alti del discorso di Aquisgrana, mette in evidenza la necessità di una condizione fondamentale e necessaria per la riunificazione, ossia la formazione della «mentalità europea»: «Di pari passo però con il rafforzamento e l’accrescimento di potere delle istituzioni federali, devono procedere i progressi di una mentalità europea. Le istituzioni supernazionali sarebbero insufficienti e rischierebbero di diventare una palestra di competizioni di interessi particolari, se gli uomini ad esse preposti non si sentissero mandatari di interessi superiori ed europei. Senza la formazione di questa mentalità europea ogni nostra formula rischia di rimanere una vuota astrazione giuridica».
L’11 maggio 1954 De Gasperi è eletto all’unanimità presidente dell’Assemblea della CECA: è un grande riconoscimento per uno statista e politico europeista come lui che, dopo la fine della Seconda guerra mondiale, ha dedicato tanto lavoro non solo alla ricostruzione dell’Italia ma anche alla costruzione dell’unità in Europa.
A Strasburgo, De Gasperi accetta la nomina a presidente dell’Assemblea comune della CECA e pronuncia un forte discorso europeista sostenendo la causa della ratifica della CED: mancavano solo le ratifiche dell’Italia e della Francia, e quest’ultima si presentava particolarmente difficile .
Nel discorso di Strasburgo, innanzi all’Assemblea comune della CECA, ribadisce l’impegno a continuare l’opera avviata da Robert Schuman e da Jean Monnet, auspicando ulteriori sviluppi sulla via dell’unità europea. Il neopresidente De Gasperi invita tutti i membri, soprattutto nei momenti di difficoltà impreviste, a non dimenticare l’obiettivo e la ragion d’essere del comune lavoro – che è l’«organizzazione della pace» – e a non far mancare il «senso di responsabilità» e di «corresponsabilità più ampio di quella che è la competenza specifica della Comunità».
Il 30 agosto 1954 – undici giorni dopo la sua morte (Sella di Valsugana, 19 agosto) – il Parlamento francese non ratifica il trattato della CED ed il progetto va alla deriva; ma l’opera dello statista trentino rimane, in parte, incompiuta: come rileva Jean-Dominique Duran «il metodo funzionalista ripreso nelle Conferenze europee successive (Messina, Venezia) e con i Trattati di Roma del 1957, e i suoi moniti sulla necessaria unità politica, sul rispetto delle nazioni nella costruzione di tale entità politica, sui contenuti che non possono essere soltanto di tipo tecnico ma devono portare avanti un vero ideale europeistico al quale fare aderire i popoli, restano attualità» (cfr. Jean-Dominique Durand, Alcide De Gasperi e la Patria europea, in Giuseppe Tognon (a cura di), Su De Gasperi. Dieci lezioni di storia e di politica, FBK Press, Trento 2013, p. 72).
Secondo Igino Giordani è “l’unità” la mèta verso cui De Gasperi ha camminato, scalando rocce acuminate e oscillanti (cfr. Igino Giordani, Alcide De Gasperi, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1955, p. 361).
L’anno precedente alla sua morte, De Gasperi, in occasione della seduta pubblica d’apertura della Tavola rotonda d’Europa (Roma, 13 ottobre 1953), pronuncia le seguenti parole: «La tendenza all’unità è – mi sembra – una delle “costanti” della storia […] noi lavoriamo per l’unità, non per la divisione […]».
Il pensiero, le opere e la testimonianza di Alcide De Gasperi sono perciò di grande attualità.
(Tratto da www.cittanuova.it)
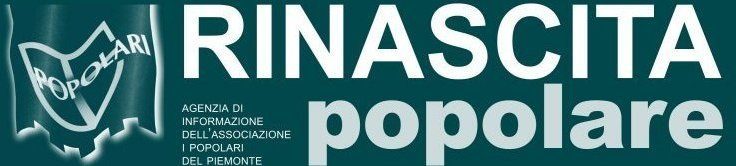
Lascia un commento