
Difesa comune europea: potremmo dire la scelta migliore nel momento peggiore. Il vecchio continente vive infatti il suo più difficile frangente dalla fine della Seconda guerra mondiale, trovandosi alle prese con il conflitto tra Russia ed Ucraina. Per di più, ad un contesto già drammatico di suo, si aggiunge il manifesto disimpegno di Washington dalla Nato e dallo scacchiere europeo.
Nulla di veramente inatteso però. Già prima di Donald Trump, sia Joe Biden che Barack Obama, avevano chiesto un più forte contributo europeo in ambito Nato, portando le spese militari di ciascun Paese al due per cento del Pil. Adesso semplicemente, questo discorso, nell'aria da anni, sta subendo una forte accelerazione. E peraltro non è ancora ben chiaro se il futuro sistema difensivo europeo continuerà ancora ad incardinarsi nella Nato - seppur con un'inevitabile diversa suddivisione dei pesi tra le due sponde dell'Atlantico - o se invece ci si stia incamminando verso uno sganciamento dagli Stati Uniti.
In ogni caso stiamo riprendendo un cammino interrotto nel lontano 1954 quando la Francia inopinatamente bocciò la Comunità europea di difesa (Ced) cui partecipavano Italia, Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo. I sei Paesi che tre anni dopo diedero vita alla Cee di cui l'attuale Unione è l'evoluzione storica. E bisogna dire che, in barba ai sovranisti d'ogni dove, quella dell'Unione è una vicenda di successo perché, seppure l'integrazione vada a rilento, si è passati ad una comunità di ventisette membri e almeno altri dieci Stati bussano alla sua porta.
Per far tornare in agenda il tema della difesa ci voleva un'amministrazione americana ostile come non mai al vecchio continente. Un'avversione talmente marcata da far non solo ricompattare i ventisette ma capace persino di riavvicinare Londra e Bruxelles. In freddo dopo la Brexit. D'altronde un'efficace protezione europea non può prescindere dalla Gran Bretagna. Al di là della sua appartenenza all'Ue, essa è infatti una potenza nucleare assieme alla Francia che, peraltro, pare intenzionata a condividere la forza di dissuasione con il resto dell'Europa.
Se si parla di difesa comune bisogna però intendersi, poiché il concetto può venir declinato in tante maniere. Il piano della Commissione europea prevede un finanziamento pluriennale di 800 miliardi e lo scorporo delle spese militari dal debito pubblico dei singoli Stati. Un passo importante ma non sufficiente. Il rischio è che ogni Stato incrementi per conto proprio la spesa militare e sia costretto poi a ridurre i finanziamenti alla sanità pubblica e via dicendo. Qualcosa di inaccettabile: socialmente ed eticamente. Una trappola da scongiurare.
La via di uscita più sensata è di centralizzare la spesa a livello europeo, poiché solo una gestione coordinata creerà le economie di scala indispensabili per evitare tagli al welfare. E questa è una prima condizione. Ma poi serve un passo ulteriore. Si tratta cioè di impiegare risorse non soltanto tratte dai bilanci dei singoli Stati - che appesantirebbero i rispettivi debiti pubblici nazionali - ma disporre di un fondo sovranazionale proveniente dal bilancio comunitario. Bilancio che purtroppo oggi si colloca attorno all'uno per cento del Pil dell'Unione: non in grado di coprire lo sforzo richiesto e che va dunque innalzato all'otto-dieci per cento. Percentuale che sarebbe comunque sempre meno della metà del bilancio federale statunitense.
Questo per quanto riguarda la cornice finanziaria. Entrando invece nel merito della spesa è insensato continuare con l'attuale dispersione di mezzi, strumenti ed equipaggiamenti. Si impone in tempi brevi una standardizzazione con pochi modelli per ciascun tipo di armamento. Un percorso irto di ostacoli, scontrandosi con l'interesse dei singoli Stati volti a privilegiare le proprie industrie. Eppure la strada è quella di un'armonizzazione tra i vari produttori, oggi in concorrenza tra loro, e chiamati, come avviene nel settore automotive, a creare delle sinergie. Altrettanto decisivo sarà di acquistare sul mercato europeo quello che possiamo produrre in casa, altrimenti andremmo ad ingrassare le imprese americane.
Ci vorrà tempo per tutto questo, ma soprattutto una chiara volontà politica. In caso contrario la difesa comune non sarà altro che il paravento dietro cui si nasconde la corsa al riarmo tra campioni nazionali mal coordinati tra loro. Gara che farebbe guadagnare soltanto enormi profitti alla lobby delle armi, senza realizzare un modello integrato di difesa.
A monte di tutto va posta però una questione decisiva. Non possiamo rassegnarci a vivere in un clima di perenne tensione internazionale. Va perseguita, in tutti i modi, a livello globale una riduzione degli armamenti, imboccando la via della distensione e della coesistenza pacifica. Unico traguardo capace di garantire una vera sicurezza per tutti.
Nulla di veramente inatteso però. Già prima di Donald Trump, sia Joe Biden che Barack Obama, avevano chiesto un più forte contributo europeo in ambito Nato, portando le spese militari di ciascun Paese al due per cento del Pil. Adesso semplicemente, questo discorso, nell'aria da anni, sta subendo una forte accelerazione. E peraltro non è ancora ben chiaro se il futuro sistema difensivo europeo continuerà ancora ad incardinarsi nella Nato - seppur con un'inevitabile diversa suddivisione dei pesi tra le due sponde dell'Atlantico - o se invece ci si stia incamminando verso uno sganciamento dagli Stati Uniti.
In ogni caso stiamo riprendendo un cammino interrotto nel lontano 1954 quando la Francia inopinatamente bocciò la Comunità europea di difesa (Ced) cui partecipavano Italia, Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo. I sei Paesi che tre anni dopo diedero vita alla Cee di cui l'attuale Unione è l'evoluzione storica. E bisogna dire che, in barba ai sovranisti d'ogni dove, quella dell'Unione è una vicenda di successo perché, seppure l'integrazione vada a rilento, si è passati ad una comunità di ventisette membri e almeno altri dieci Stati bussano alla sua porta.
Per far tornare in agenda il tema della difesa ci voleva un'amministrazione americana ostile come non mai al vecchio continente. Un'avversione talmente marcata da far non solo ricompattare i ventisette ma capace persino di riavvicinare Londra e Bruxelles. In freddo dopo la Brexit. D'altronde un'efficace protezione europea non può prescindere dalla Gran Bretagna. Al di là della sua appartenenza all'Ue, essa è infatti una potenza nucleare assieme alla Francia che, peraltro, pare intenzionata a condividere la forza di dissuasione con il resto dell'Europa.
Se si parla di difesa comune bisogna però intendersi, poiché il concetto può venir declinato in tante maniere. Il piano della Commissione europea prevede un finanziamento pluriennale di 800 miliardi e lo scorporo delle spese militari dal debito pubblico dei singoli Stati. Un passo importante ma non sufficiente. Il rischio è che ogni Stato incrementi per conto proprio la spesa militare e sia costretto poi a ridurre i finanziamenti alla sanità pubblica e via dicendo. Qualcosa di inaccettabile: socialmente ed eticamente. Una trappola da scongiurare.
La via di uscita più sensata è di centralizzare la spesa a livello europeo, poiché solo una gestione coordinata creerà le economie di scala indispensabili per evitare tagli al welfare. E questa è una prima condizione. Ma poi serve un passo ulteriore. Si tratta cioè di impiegare risorse non soltanto tratte dai bilanci dei singoli Stati - che appesantirebbero i rispettivi debiti pubblici nazionali - ma disporre di un fondo sovranazionale proveniente dal bilancio comunitario. Bilancio che purtroppo oggi si colloca attorno all'uno per cento del Pil dell'Unione: non in grado di coprire lo sforzo richiesto e che va dunque innalzato all'otto-dieci per cento. Percentuale che sarebbe comunque sempre meno della metà del bilancio federale statunitense.
Questo per quanto riguarda la cornice finanziaria. Entrando invece nel merito della spesa è insensato continuare con l'attuale dispersione di mezzi, strumenti ed equipaggiamenti. Si impone in tempi brevi una standardizzazione con pochi modelli per ciascun tipo di armamento. Un percorso irto di ostacoli, scontrandosi con l'interesse dei singoli Stati volti a privilegiare le proprie industrie. Eppure la strada è quella di un'armonizzazione tra i vari produttori, oggi in concorrenza tra loro, e chiamati, come avviene nel settore automotive, a creare delle sinergie. Altrettanto decisivo sarà di acquistare sul mercato europeo quello che possiamo produrre in casa, altrimenti andremmo ad ingrassare le imprese americane.
Ci vorrà tempo per tutto questo, ma soprattutto una chiara volontà politica. In caso contrario la difesa comune non sarà altro che il paravento dietro cui si nasconde la corsa al riarmo tra campioni nazionali mal coordinati tra loro. Gara che farebbe guadagnare soltanto enormi profitti alla lobby delle armi, senza realizzare un modello integrato di difesa.
A monte di tutto va posta però una questione decisiva. Non possiamo rassegnarci a vivere in un clima di perenne tensione internazionale. Va perseguita, in tutti i modi, a livello globale una riduzione degli armamenti, imboccando la via della distensione e della coesistenza pacifica. Unico traguardo capace di garantire una vera sicurezza per tutti.
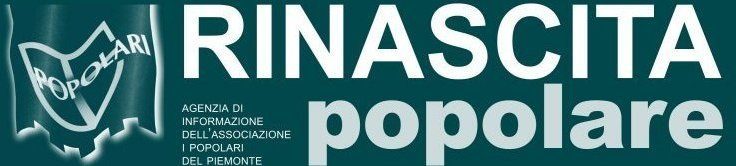
Che l’unità del servizio alla politica dei cattolici si possa ricostruire a partire dal consapevole disarmo dell’Europa?
L’articolo di Aldo Novellini, visti i tempi che corrono è equilibrato e dice cose di buon senso, specie nel finale. Ovvio che la grancassa del ” dagli al russo cattivo” non solo è attiva a pieni giri ma ..sta andando velocemente fuori giri. Draghi docet , maestro di sventure e bugie ci vuole poveri e inginocchiati davanti alla rinascita del potere tedesco, Non pochi paragonano il riarmo attuale agli anni dal 1933 al 1940 in Germania con le fabbriche di armi in piena attività. La maggior parte degli analisti stimano che del totale di 800 miliardi ben 500 andranno alla sola Germania. Ognuno può farsi due conti. Aggiungo un piccolo particolare : la produzione dei famosi proiettili di mortaio da 155 è un monopolio della Rhein metall. Un proiettile di questo tipo, prima dell’invasione del Donbass costava 800 euro, nell’agosto 2024 costava 3600 euro.
Chiudo riportando una notizia che al di fuori del Fatto Quotidiano e la Verità tutti hanno taciuto, specie la tv. La sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, emessa lo scorso 13 marzo , condanna alla unanimità la Ucraina per il massacro di Odessa del 2014 presso la casa dei sindacati , dove furono bruciate vive 42 persone. Ricordiamoci che i buoni per i quali ci armiamo ed indebitiamo sono anche questi. Riporto il dispositivo integrale della sentenza.
https://www.echr.coe.int/w/judgment-concerning-ukraine-2?fbclid=IwY2xjawJGj1NleHRuA2FlbQIxMQABHWZLZeubscafQ2aUjDVZ7yIWk2BQsQykPVZHluC-SByNc-MXQ32bKc6-ag_aem_V7WTVbcoZLfzC0YYqe1ZsA
Post scriptum : per accedere al dispositivo della sentenza dopo aver cliccato sul link rosso, nella home page con la fotografia dell’aula senza giudici, in basso digitare press release, si aprirà nuova finestra con la sentenza ( in inglese).
Aldo Novellini ci offre una adeguata rappresentazione del dibattito sulla difesa europea evidenziando i dubbi, le incertezze e le questioni ancora aperte a differenti soluzioni.
Ciò che manca (non nell’esposizione di Novellini, ma nel dibattito) è una corretta rappresentazione della attuale spesa europea in armamenti. Come scritto in un recente mio articolo, la spesa militare dell’insieme dei paesi della UE è decisamente elevata già oggi (senza ancora aver raggiunto il 2% del Pil) ponendo l’Europa comunitaria al terzo posto al mondo dopo Usa e Cina e ben più avanti della Russia. E ciò sia considerando detta spesa in dollari internazionali (come fa il Sipri), sia considerandola a parità di potere d’acquisto in dollari correnti(come fanno altre agenzie).
Da parte dei responsabili politici ai vertici delle istituzioni, neanche una parola in argomento, mentre tale fatto viene riconosciuto da vari commentatori che attribuiscono la debolezza militare dell’Europa comunitaria alla mancanza di integrazione e di coordinamento fra le forze militari dei paesi che la compongono.
Occorre però spiegare il perché di tale situazione. In realtà ciò non è dovuto solo a responsabilità dei vertici politici e/o militari europei, ma soprattutto al fatto che gli eserciti delle nazioni della Comunità (a parte la Francia in cui rimane presente l’eredità di De Gaulle), per pluriennale volontà di Washington, mancano di taluni armamenti e/o di specifici sistemi di arma in settori vitali, e pertanto possono agire solo nel quadro Nato a supporto delle forze dello Stato guida. E se l’America, in un qualsivoglia contesto, fa un passo indietro, detti eserciti non sono più in grado di agire efficacemente, e la UE resta senza difesa.
Giustamente, scrive Novellini, non è ancora ben chiaro se il ventilato sistema difensivo europeo continuerà ancora ad essere incardinato nella Nato, o se invece ci si stia incamminando verso uno sganciamento dagli Stati Uniti.
Ora, se il coordinamento e l’integrazione delle forze milita europee resta in ambito Nato, e quindi inevitabilmente a guida statunitense, ben poco cambierà rispetto ad oggi, anche incrementando la spesa europea.
L’alternativa per i paesi della UE consiste, con uno sganciamento dagli Usa, nel coordinarsi ed organizzarsi al di fuori della Nato, o meglio nella creazione di un autonomo esercito europeo. Impresa che, tuttavia, presenta notevoli difficoltà politiche e tecnico-organizzative, e che richiede tempi lunghi, comunque incompatibili con un sostegno all’Ucraina sostitutivo di quello americano, di fatto una mera intenzione palesemente velleitaria.
Ricordo infine una considerazione fatta più volte da Dario Fabbri. Non bastano le armi ad un paese per far sentire la sua voce in campo internazionale se, quando necessario, non è disposto a mandare i suoi giovani, i suoi figli, a morire sui campi di battaglia. Chiediamoci chi in Europa vorrà farlo per Kiev.
Esprimo le mie più intense e preoccupate perplessità rispetto al dibattito che si sta sviluppando sul sito tra articolisti vari e commentatori. Ciò che manca non è una corretta rappresentazione della attuale spesa europea in armamenti, bensì la consapevolezza e la conoscenza di una circostanza, non banale, che ripeto in ogni mia riflessione: L’OROLOGIO DELLA STORIA è ANCORA SINCRONIZZATO SUI PATTI DI YALTA DEL 1945 STABILITI DA ROOSEVELT, STALIN E CHURCHILL CHE INSIEME COOPTARONO CHIANG KAI-SHEK E DE GAULLE PER INTERESSI GEOPOLITICI. Tradotto significa che coloro che hanno l’autorità per decidere sono solo USA, Federazione Russa (erede dell’URSS) e United Kingdom, con aggregati in secondo ordine Cina Comunista usurpatrice (per volontà del pessimo duo Nixon-Kissinger) della Cina Nazionalista di Chiang Kai-Shek (riparato a Taiwan) e Francia. Solo all’interno di questa cornice è possibile comprendere da dove veniamo, cosa sta succedendo e dove stiamo andando (verso il baratro)! Ribadisco che solo il completamento del percorso verso l’unità polita europea (di Stati, federazione o quant’altro non ha importanza) avviata da Alcide de Gasperi, Robert Schumann e Konrad Adenauer, democratici cristiani, non il Manifesto di Ventotene pur pregevole, potrà portare ad un nuovo Ordine Mondiale pacifico, solidale e rispettoso delle storie e delle culture di ogni soggetto. Non è mio costume citare gli articolisti, farò una eccezione per scrivere che Novellini ha il merito di proporre sempre questioni concrete e reali non voli pindarici. Ricordo con grande affetto verso tutti che la comprensione degli eventi non passa per autori internazionali vari ma, per quel che riguarda i popolari autenticamente “Liberi e Forti”, passa per la lettura continua e la comprensione dei PENSIERI di Luigi Sturzo, Alcide de Gasperi e Aldo Moro, pensieri compresi e riattualizzati, tra i pochi Politici, da Mino Martinazzoli e il nostro Guido Bodrato. Auguri a voi per le vostre riflessioni.
Maurizio Trinchitella
Socio fondatore con Guido Bodrato della Associazione “I Popolari del Piemonte” nello Studio Tavolaccini in quel di Biella (VC)
Secondo molti osservatori il riarmo europeo , processo che certamente non sarà di breve durata, favorirà soprattutto la Germania che possiede le condizioni industriali per avviare una produzione quantitativamente e qualitativamente credibile. Oltre all’Olanda che è l’unico paese a detenere il necessario know how nel campo dei microprocessori. La necessità di una gestione condivisa del potenziale militare appare a questo punto cruciale: con le indispensabili attualizzazioni dovrà essere rilanciata l’ispirazione originaria della Comunità europea di difesa; perché altrimenti ci troveremo di fronte a un forte riarmo non tanto europeo ma principalmente tedesco e a una rinnovata competizione fra Francia (che possiede l’arma nucleare) e Germania per ottenere una sorta di supremazia nella guida politica dell’Unione. Dietro il riarmo tedesco si nasconde una nuova strategia di potenza? Gli Stati Uniti hanno sempre guardato con diffidenza al riarmo tedesco, il timore di una replica delle note vicende storiche (dalle manovre del primo cancelliere della Repubblica di Weimar Muller alle cambiali Mefo emesse durante il terzo Reich per eludere i divieti stabiliti a Versailles) non li ha mai, giustamente, abbandonati. Proprio la creazione di una CED potrebbe allontanare il fantasma di una Germania potenzialmente aggressiva se non addirittura di un conflitto intraeuropeo